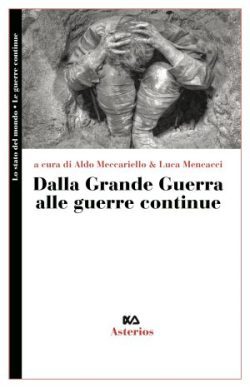Indice: 1. Grande Guerra e religioni politiche, 2. La Grande Guerra, secolarizzazione ed evaporazione del divino nel mondo, 3. Le due religioni politiche: nazionalismo e internazionalismo, la politicizzazione integrale della vita, 4. Nazionalismo postbellico e figura del nemico interno, 5. La rivoluzione quale punto alto della secolarizzazione e la differenza fra la visione di sinistra e quella di destra in materia di rivoluzione
1. Grande Guerra e religioni politiche
È recente un giudizio che, tenendo presenti le tendenze del dibattito storiografico degli ultimi decenni, interpreta la Grande Guerra come vicenda che aveva inaugurato nuovi scenari storico-politici:
È la guerra a mandare in frantumi la credibilità di una storia-progresso dominata dalla scienza e dalla tecnologia. È la guerra a rendere più forti e credibili (nel senso che le legittima e le rende plausibili) le alternative antiliberali, antiparlamentari, antidemocratiche. È la guerra a introdurre una “biopolitica” che assegnava allo Stato il potere di disporre dei corpi e delle vite degli esseri umani. È la guerra a introdurre un’economia dirigista e centralizzata, a sospendere diritti civili e politici, a costruire l’ideologia del nemico, l’assuefazione alla violenza, la sottomissione dei mezzi ai fini, l’interferenza dello Stato sulla società civile. Tutti aspetti che la fine della guerra non cancella e che anzi sono destinati a ripresentarsi più volte nel corso della storia successiva. (Flores e Gozzini 2012, p. 174)
In questo giudizio, peraltro ampiamente condivisibile, ciò che appunto risulta mancante è la questione se esista o meno un rapporto fra la Grande Guerra e il successivo emergere delle religioni politiche.
La storiografia sul Novecento ha oscillato lungo tre poli tematici, ovvero veri e propri modelli interpretativi. Invero, prima di delineare sommariamente i tre modelli interpretativi, è il caso di segnalare che c’è un quarto modello, quello costruito attorno al concetto di “guerra civile europea”, proposto da Ernst Nolte (cfr., Nolte 1988). Qualche considerazione in proposito è necessaria.
Oltre a suscitare numerose critiche nell’ambito storiografico, il cosiddetto Historikerstreit, quello noltiano era parso troppo debitore dalle vicende storiche tedesche per essere proiettato nel panorama storico europeo. Esso si presentava quale espressione di un revisionismo storiografico in cui erano aboliti, quasi programmaticamente, i confini, fra la ricerca storica e lo Zeitgeist neoconservatore e neoliberale che animava lo stesso Nolte. “Il revisionismo storiografico – era stato osservato a proposito delle posizioni di Nolte – è funzionale od organico alla cultura politica neoconservatrice oggi in posizione preminente in tutti i Paesi occidentali, il suo obiettivo specifico consiste nella normalizzazione di nazismo e fascismo” (Poggio 1997, p. 14). Nella chiave di lettura di Nolte aleggiava, secondo i suoi critici, il sospetto che il nazismo si fosse incaricato del compito di difendere il continente europeo dall’avanzata del bolscevismo: un compito che, fatte salve le declinazioni razziste e antisemite – il bolscevismo quale traduzione politica della barbarie asiatica e della sete di dominio dell’ebraismo –, sembrerebbe avallare le posizioni del Goebbels del 1945, il gerarca che, con toni infuocati e apocalittici, chiamava i tedeschi a resistere fino all’ultimo contro l’avanzata delle armate sovietiche.
La chiave di lettura proposta da Nolte è importante perché presenta qualche aspetto riconducibile al pensiero politico conservatore. Tracce di “noltismo” sono rintracciabili, a titolo di puro esempio, in uno dei più autorevoli storici del bolscevismo, Richard Pipes. Ad avviso di Pipes, considerato che “le basi del regime bolscevico furono poste fra il 1917 e il 1918” (Pipes 2000, p. 280), si può parlare di “influenza del bolscevismo su fascismo e nazionalsocialismo” (ivi, p. 281). D’altro canto, il bolscevismo è da inquadrare nella tradizione del radicalismo intellettuale russo: gli intellettuali “non volevano la rivoluzione per migliorare le condizioni della gente, ma per ottenere il dominio sulla popolazione, e rimodellarla a propria immagine” (ivi, p. 564; ma cfr. anche p. 277). Con i vari Nolte, Pipes ecc. siamo a Burke, nume tutelare del pensiero conservatore, riattualizzato per discutere i problemi della storia del Novecento; e non a caso, l’influenza di Burke è avvertibile nel variegato ambito del revisionismo storico (cfr., Losurdo 1996).
E tuttavia, neanche il richiamo a Burke risulta utile per spiegare il fenomeno delle religioni politiche, perché se si accettasse che fascismo e nazismo costituivano un’imitazione del bolscevismo, si dovrebbe dedurre che le religioni politiche erano state un fenomeno storico importato nell’Europa occidentale dall’arretrata, economicamente e socialmente, Europa dell’Est. Si potrebbe obiettare che i bolscevichi erano intellettuali formatisi nella cultura europea (il marxismo, soprattutto). Ma questo sarebbe aporetico col giudizio secondo cui essi rappresentavano il radicalismo espresso da decenni dall’intellighenzia russa. In ogni caso, poi, le ricostruzioni dei vari Nolte, Pipes ecc. non spiegano il motivo dell’apparizione delle religioni politiche nell’epoca della secolarizzazione.
Vediamo brevemente i tre modelli cui si faceva riferimento. Il primo concerne la fin troppo nota proposta di Eric Hobsbawn sulla Grande Guerra quale vicenda che aveva inaugurato il “secolo breve”, chiusosi con la caduta dei regimi comunisti. Così lo storico inglese: “il grande edificio della civiltà ottocentesca crollò tra le fiamme della guerra mondiale e i suoi pilastri rovinarono al suolo. Senza la guerra non si capisce il Secolo breve, un secolo segnato dalle vicende belliche, nel quale la vita e il pensiero sono stati scanditi dalla guerra mondiale, anche quando i cannoni tacevano e le bombe non esplodevano” (Hobsbawn 1995, p. 34).
Il secondo modello, proposto da George L. Mosse, aveva letto la Grande Guerra quale affermarsi della “brutalizzazione della vita”, una brutalizzazione poi tradottasi, negli anni del dopoguerra, nel ricorso alla violenza a fini politici (squadrismo fascista, SA naziste, comunismo di guerra e poi collettivizzazione forzata ecc.). Così Mosse:
Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell’Esperienza della Guerra aveva dato al conflitto una nuova dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il prolungarsi degli atteggiamenti degli anni di guerra in tempo di pace incoraggiò una certa brutalizzazione della politica, un’accentuata indifferenza per la vita umana. […] Dopo il 1918, nessuna nazione poté sfuggire completamente al processo di brutalizzazione. […] La guerra era divenuta parte della vita di molta gente, e ciò non poté non influenzare negativamente i comportamenti postbellici. […] La natura umana divenne primitiva, istintiva, violenta (Mosse 1990, pp. 175-9).
Prossima a quella di Mosse è l’interpretazione storiografica di Emilio Gentile:
Dopo oltre quattro anni di combattimenti, la violenza era diventata una nuova abitudine di comportamento per milioni di uomini che erano stati al fronte, e molti di essi la consideravano ora uno strumento legittimo per distruggere il vecchio mondo e crearne uno nuovo: praticata nelle trincee, la violenza fu adottata nella politica alla conclusione del conflitto. (Gentile, 2008, p. 15)
La Grande Guerra familiarizzando gli uomini con la pratica della violenza, aveva inaugurato una fase storica in cui non solo l’azione politica poteva prevedere il ricorso alla violenza – e dunque la stessa azione politica, per essere ritenuta efficace, prevedeva la violenza –, ma quest’ultima, da strumento cui fino ad allora si era ricorso nelle situazioni eccezionali, risultava anche normalizzata. La presenza sulla scena politica del dopoguerra di movimenti politici rivoluzionari di destra come di sinistra aveva trovato uno dei motivi nel fatto che erano caduti quegli scrupoli verso il ricorso alla violenza dettati dalle culture precedenti, a cominciare da quelle religiose: erano scrupoli che, fino ad allora, avevano frenato il ricorso alla violenza, derubricandola quale opzione estrema dettata da situazioni eccezionali.
C’è infine – e siamo al terzo modello – il rapporto stretto fra guerra e fascismo, un rapporto valorizzato da Renzo De Felice, convinto che la Grande Guerra avesse incubato la soluzione fascista.
Comunque si vogliano giudicare queste posizioni, esse avevano comunque proceduto, soprattutto le ultime due, a una storicizzazione dei risultati della Grande Guerra. “Fu la prima guerra mondiale – aveva sostenuto De Felice nella sua famosa Intervista sul fascismo – che mobilitò tutta una parte della società italiana, restata sino allora in disparte. E questa parte, mobilitata per la guerra, epperò esclusa dal potere effettivo, dalla partecipazione, tende poi, attraverso il fascismo, a rivendicare, ad acquistare una sua funzione” (De Felice 1975, p. 31). E poi nella stessa sede, precisando ancor di più la sua posizione storiografica, in implicita polemica con alcuni settori della storiografia italiana di orientamento marxista: “Io sono fermissimo nel ritenere che il fascismo sia un fenomeno che si può e si deve circoscrivere rigidamente, altrimenti non capiamo più niente: circoscrivere cronologicamente, fra le due guerre mondiali; circoscrivere geograficamente in Europa, e sostanzialmente nell’Europa occidentale” (ivi, p. 82). Fin qui la storiografia.
È il caso, ora, di cominciare a verificare il rapporto fra la Grande Guerra e le religioni politiche. Che queste avessero trovato udienza nel mercato politico e delle idee nel dopoguerra, è un dato storiografico appena da rilevare. Eppure, nel caso dei tre modelli storiografici delineati sommariamente in precedenza quel rapporto risultava trascurato.
Quanto alla scienza politica, emblematico è il caso di Eric Voegelin, autore su cui talvolta ritorneremo, tra i primi, nel 1938, a problematizzare il concetto di “religione politica”, sia pure limitandolo al caso del nazionalsocialismo (cfr., Voegelin 1993). In Voegelin, in forza anche dell’impostazione teorico-politica del testo, non compaiono riferimenti al rapporto fra l’affermarsi delle religioni politiche e la guerra. Anzi, proprio un testo fondamentale come quello di Voegelin può essere richiamato per delineare una delle domande all’origine del nostro percorso: perché proprio nell’epoca dell’Entzauberung e di processi di secolarizzazione sempre più tumultuosi il mercato politico e delle idee aveva visto l’affermarsi delle religioni politiche?
Anche nel pensiero economico non erano mancati riferimenti alla tendenza della politica a declinarsi come religione, pure se mancavano riferimenti alla guerra. Keynes, in un saggio del 1925, col nazismo ancora lontano dalla presa del potere e il fascismo appena uscito dalla crisi provocata dall’omicidio di Matteotti, assumeva come laboratorio l’Urss, presentando il bolscevismo come una religione politica:
Il leninismo è la combinazione di due cose che per secoli gli europei hanno tenuto in diversi compartimenti dello spirito: la religione e gli affari. Noi siamo sconcertati perché è un nuovo tipo di religione […] Come altre nuove religioni, il leninismo trae il suo potere non dalla moltitudine, ma da una piccola minoranza di convertiti entusiasti, ciascuno dei quali è animato da tanto zelo e tanta intolleranza […]. Come altre nuove religioni, è pieno di ardore missionario e ambizioni ecumeniche. Ma dire che il leninismo è la fede di una minoranza persecutrice e proselitista di fanatici guidati da ipocriti vale a dire, in sostanza, né più né meno che il leninismo è una religione, non un semplice partito, e che Lenin è un Maometto, non un Bismarck. (Keynes 2010, pp. 179-180)
Non sarebbe stato del tutto diverso, il giudizio di Joseph A. Schumpeter, all’inizio di un capitolo di Capitalismo, socialismo democrazia del 1954, significativamente intitolato “Marx profeta”. Ad avviso dell’economista austriaco,
il marxismo è una religione. Esso offre al credente, anzitutto, un sistema di fini ultimi che racchiudono il significato profondo della vita e valgono come criteri assoluti di giudizio dei fatti e delle azioni; in secondo luogo, una guida a questi fini, che implica un piano di salvezza e l’indicazione del male da cui l’umanità, o almeno una sua parte privilegiata, deve essere salva. (Schumpeter 1977, p. 5)
Più articolato, ma proprio per questo ancor più discutibile sul piano storiografico, il giudizio, a seconda guerra mondiale in corso, di Von Hayek, secondo il quale l’avvento del nazismo aveva visto un’improbabile convergenza fra il socialismo di sinistra e la destra, con l’obiettivo di eliminare qualsiasi traccia di liberalismo. Così l’economista austriaco:
Le dottrine che hanno guidato la classe dominante dell’ultima generazione in Germania si opponevano non al socialismo in quanto marxismo, ma agli elementi di liberalismo che vi erano contenuti, al suo internazionalismo e alla sua democrazia. E quando divenne ancora più chiaro che erano proprio questi elementi che si frapponevano alla realizzazione del socialismo, i socialisti di sinistra si accostarono sempre più alla destra. Fu l’unione delle forze anticapitalistiche di destra e di sinistra, la fusione tra socialismo radicale e conservatore che spazzò via dalla Germania qualunque cosa fosse liberale. (Von Hayek 1995, 223)
Keynes e Schumpeter erano solo gli esponenti più rappresentativi di una corrente del pensiero economico e sociologico occidentale caratterizzatasi per l’insistenza nel sottolineare il carattere religioso del marxismo e del socialismo (cfr., Pellicani 1978, in part. p. 77, nota 5; Id., 2012). Ai fini del nostro discorso, ci limitiamo a rimanere a Keynes.
Il tono aspro e polemico dell’economista inglese, che respingeva non solo il bolscevismo, ma Il Capitale, presentato come un “obsoleto manuale di economia […] scientificamente erroneo“ (Keynes 2010, p. 181), inibiva a Keynes di comprendere sia le cause del successo del bolscevismo in Russia, sia quelle delle simpatie che riscuoteva in Europa, almeno presso alcuni settori delle classi subalterne. Ma erano proprio questi limiti, a loro volta, che permettevano a Keynes di presentare il rivoluzionario – nella fattispecie, il rivoluzionario comunista – nella veste di un fanatico disposto a tutto, il militante disposto a sacrificare anche la propria vita, per la causa della rivoluzione proletaria: “Il soldato della rivoluzione deve crocifiggere la propria natura umana, diventando spietato e senza scrupoli, e soffrendo in prima persona una vita priva di sicurezza o gioia – ma come mezzo per raggiungere il suo scopo, e non come fine in sé” (ivi, p. 183). Fin qui Keynes.
La conseguenza è che, in Keynes come in Voegelin – più nel primo che nel secondo –, rimaneva inevaso il problema dell’origine storica delle religioni politiche; insomma, non c’era risposta sia alla domanda inerente i motivi per cui le religioni politiche comparivano sulla scena del dopoguerra, sia alla questione se ci fosse un rapporto fra la Grande Guerra e l’affermarsi delle religioni politiche nel panorama politico del dopoguerra.
Ora, che i regimi politici totalitari del primo dopoguerra presupponessero la formazione di religioni politiche, è fin troppo evidente; potremmo anche osservare che dire “religione politica” equivale a dire “totalitarismo”, nel senso che il secondo può essere ritenuto tale se il suo ambiente è pervaso dalla presenza della prima. Se la categoria di “totalitarismo” compariva nel dibattito teorico-politico nei mesi successivi alla marcia su Roma (cfr., Gentile 2023), quella di “religione politica” inizia a diffondersi attorno agli anni Trenta, in contemporanea con l’affermarsi del nazismo. Fra fascismo, comunismo e nazismo il panorama politico europeo era ormai costellato dalla presenza di Regimi totalitari che declinavano in una chiave religiosa il loro immaginario politico.
Ora, almeno per rimanere alle prime mosse del governo fascista, questo scarto temporale fra l’affermarsi sulla scena politica europea dei regimi totalitari e il ricorso al concetto di “religione politica”, non limitato, come nel caso di Keynes, al bolscevismo, ma da estendere anche al fascismo, era stato probabilmente provocato anche dal fatto che l’attenzione degli osservatori si era focalizzata soprattutto nella sottolineatura del modo spregiudicato di gestione degli apparati repressivi dello Stato da parte del fascismo appena al potere rispetto alla definizione degli aspetti dei nuovi universi ideologici. Il politico liberale Giovanni Amendola, al quale nel 1923 si deve per primo l’utilizzo del concetto di “totalitarismo”, nelle sue analisi aveva insistito sulle distorsioni politico-istituzionali provocate dal governo fascista, piuttosto che soffermarsi sull’ideologia:
quando non si vuole – osservava Amendola nella sua denuncia – un’opposizione come non la vuole il fascismo c’è modo di dare a questa volontà una forma legale e non arbitraria. Così fecero i passati governi assoluti, così ha fatto, ai nostri giorni, il governo bolscevico; si è dato cioè valore legale ad una particolare concezione dello Stato e ad una particolare pratica di governo […]. Il fascismo non ha assunto questa posizione, e cioè non ha voluto creare una nuova legalità escludente, come la legalità legittimistica o bolscevica. (Amendola 1974, p. 349)
Un politico schiettamente liberale come Amendola non poteva che insistere sull’inesistenza del senso di legalità del governo fascista, sottovalutando che la spinta ad assumere atteggiamenti illegali, ossia il ricorso a una violenza squadrista che continuava anche a fascismo al governo, costituiva un tassello decisivo del mosaico ideologico fascista.
Per tornare al nostro tema, non c’è stato nessun regime politico totalitario che non fosse ispirato e “occupato” da una religione politica. Un regime totalitario può funzionare solo in quanto è capace di trasmettere alle masse una religione politica. Almeno per quanto riguarda l’Italia, nel corso degli anni Novanta gli studi di Emilio Gentile sul fascismo quale regime caratterizzato dalla declinazione dell’ideologia in religione politica, avevano inaugurato un nuovo atteggiamento storiografico nell’analisi del regime fascista (cfr., Gentile 1993). Concludendo la sua analisi della politica nell’Italia fascista, lo storico aveva osservato che
al processo di autonomizzazione e di laicizzazione del potere politico, si è accompagnato, un processo di sacralizzazione della politica. Dalla fine del XVIII secolo, ma soprattutto nel XX secolo, c’è stata, cioè, una tendenza della politica a costruire propri universi simbolici a carattere religioso, spesso assimilando liturgia, linguaggio e modello organizzativo della tradizione cristiana, adattandoli ai propri valori secolari, per conferire a questi ultimi un’aura sacrale. […] Tutte le rivoluzioni moderne sono state creazioni o innovazioni di simboli, miti e riti che, con diversa intensità, hanno conferito una potenza numinosa al potere politico. Entità della moderna politica di massa – nazione, razza, classe, Stato, partito o capo – hanno richiesto ed hanno suscitato atti di devozione totale che erano tipici della devozione religiosa tradizionale. Persino nelle società dove più radicale è stato il processo di laicizzazione o di deliberata scristianizzazione, si sono manifestate queste nuove forme di religiosità secolare e di misticismo politico. (ivi, pp. 302-3)
Simile a questa, la definizione che Gentile avrebbe fornito successivamente:
“La religione della politica riguarda il modo in cui l’attività politica è concepita, vissuta e rappresentata attraverso credenze, miti, riti e simboli riferiti a un’entità secolare sacralizzata, che ispira fede, devozione e coesione fra i suoi credenti, prescrive un codice di comportamenti e uno spirito di dedizione per la sua difesa e il suo trionfo” (Id. 2001, p. 206).
Riconosciuto che il processo per cui la politica si era declinata come religione rimontava al XVIII secolo – e qui il riferimento non poteva che essere alla Rivoluzione francese, in particolare al giacobinismo –, rimane pur sempre da risolvere il problema dell’affermarsi delle religioni politiche nel Novecento. Inoltre, se si dovesse avanzare un’obiezione a quegli studi così innovativi, non peraltro perché avevano contribuito a sprovincializzare il dibattito storiografico italiano, se era ben chiaro il rapporto fra totalitarismo e religione politica, rimaneva da verificare se e in che modo le religioni politiche – nella fattispecie, il fascismo studiato da Gentile – fossero un problema storiografico che valicava la questione del ricorso ai riti di massa ecc. Per dire meglio: una religione politica è tale solo in quanto si concretizza nei riti politici cui partecipavano masse devote quanto entusiaste, oppure questi riti presupponevano processi politici e culturali – forse, prima questi che quelli – che poi avrebbero dato vita ai riti in ambiente politico totalitario? E la constatazione che le religioni politiche avrebbero trovato uno spazio di realizzazione negli anni successivi alla fine della prima guerra mondiale era poco più che una casualità oppure esisteva un rapporto fra le due vicende storico-politiche?
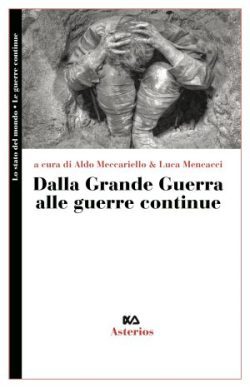
https://www.asterios.it/catalogo/dalla-grande-guerra-alle-guerre-continue
2. La Grande Guerra, secolarizzazione ed evaporazione del divino nel mondo
Volendo ricorrere alla regola della proprietà transitiva, prima di assodare il nesso fra Grande Guerra e avvento dei regimi politici totalitari, sarebbe utile problematizzare quello fra Grande Guerra e avvento delle religioni politiche.
Sgombriamo subito il campo da un problema. In materia di religioni politiche la risposta del teologo la si può immaginare così formulata: la constatazione che la religione, espulsa dalla porta da una secolarizzazione che, nel corso della guerra, si era presentata come morte di massa e sofferenza, rientrasse trionfalmente dalla finestra, venendo sequestrata dalla politica, costituiva una conferma della presenza nell’animo umano di un inestirpabile atteggiamento religioso: l’uomo necessita di credere (cfr., Ries 1995). Questa è una risposta che molto probabilmente avrebbe condiviso anche la maggioranza degli antropologi ovvero, per riferirci al pensiero sociologico, un Durkheim.
La storiografia, rivendicando di essere una disciplina caratterizzata dall’atteggiamento disincantato, non può accontentarsi di quest’ipotesi. La storicizzazione di un fenomeno sociopolitico è una procedura laica e disincantata per definizione; e questo crediamo possa valere prescindendo dalle credenze religiose, o meno, dello storico. La procedura della storicizzazione presuppone, infatti, che i fenomeni sociali, oltre che irripetibili, siano da ricondurre alle scelte e alle convinzioni umane, senza presumere interventi extramondani; insomma, la storiografia non riconosce miracoli, e perciò non riconosce la presenza del divino nel mondo. Ora, pur ammesso che l’uomo, quando opera nel mondo, sia indotto a credere in ipotesi trascendenti, rimane aperta la questione, squisitamente storiografica, di delineare i motivi che spingono gli uomini a operare dotandosi di convinzioni extramondane.
Queste precisazioni apparentemente metodologiche presentano un risvolto utile per indagare il rapporto fra prima guerra mondiale e formazione delle religioni politiche.
Nelle trincee era evaporata la convinzione che Dio intervenisse nella storia umana, ma permaneva un atteggiamento religioso nei confronti di alcune posizioni politiche giudicate, come nel caso delle simpatie per il bolscevismo, ideologie attrezzate a garantire un futuro di pace. Mentre il riferimento al divino evaporava, perché inadeguato a spiegare le sofferenze e la violenza subìta o praticata, i riferimenti alla politica rivelavano di declinarsi in una dimensione religiosa. Era necessario avere esperito il contatto con la morte di massa e l’esercizio della violenza per convincersi che la presenza del divino nel mondo e nella storia fosse da ritenersi superflua.
La Grande Guerra può essere interpretata alla stregua di una vicenda in cui si manifesta in tutta evidenza il consolidamento del precedente processo di secolarizzazione almeno in questo senso: a contatto con la morte di massa e le sofferenze era evaporata, come s’è appena osservato, la convinzione della presenza del divino nel mondo. Ora, malgrado la propaganda di tutte le nazioni belligeranti presentasse il proprio soldato quale nuovo Gesù Cristo, pronto a sacrificarsi per la patria (cfr., Merker 2015, pp. 58 sgg.), nelle trincee e negli assalti alla baionetta ritornava, amplificata e resa ancor più drammatica, la domanda a fondamento della teodicea: se c’era un Dio, perché permetteva il male, per di più – considerata la situazione che i combattenti si trovavano ad esperire – un male, quello della morte di massa, fino ad allora inimmaginabile? Delle due, l’una: non c’era un Dio oppure – il che poteva ritenersi persino peggio – Dio si era ritirato dal mondo e aveva abbandonato gli uomini al loro destino. Perché le religioni politiche successive si affermassero nell’immaginario pubblico era necessario che le religioni rivelate perdessero di udienza, nel senso che smarrissero una parte, più o meno significativa, della loro credibilità. Uno degli aspetti più significativi della guerra era consistito in una morte di massa che si traduceva in un atteggiamento secolarizzato davanti alle vicende storiche. Proprio perché dare la morte di massa era divenuta una prerogativa degli uomini, vita, morte, e dunque la storia medesima, non dipendevano più da eventuali decisioni divine. La vita e la storia umana risultavano secolarizzate; e la secolarizzazione si era presentata nel suo risvolto più violento.
Nell’incalcolabile memorialistica di guerra, almeno in quella con più successo di pubblico, pochi, se non del tutto inesistenti, risultano i riferimenti al divino. Per Ernst Jünger, ad esempio, celebrato osservatore della situazione vissuta nelle trincee, la guerra era divenuta una “guerra di materiali”: “Cresciuti in tempi di sicurezza e tranquillità, tutti sentivamo l’irresistibile attrattiva dell’incognito, il fascino dei grandi pericoli. La guerra ci aveva afferrati come un’ubriacatura. […] Essa ci appariva azione da veri uomini. […] Lasciare la monotonia della vita sedentaria e prender parte a quella grande prova. Non chiedevamo altro” (Jünger, s.d., [ma 1987], p. 11).
Osservata da chi vi aveva partecipato, ovvero da chi l’aveva vissuta persino nelle retrovie e nel fronte interno, la Grande Guerra era interpretata quale vicenda al tempo stesso più elevata e più violenta del gigantesco processo di secolarizzazione che, nei periodi storici precedenti, aveva investito la società europea: più elevata, perché costituiva la dimostrazione più evidente dell’evaporazione del senso del divino, a causa delle sofferenze dei combattenti e del panorama della morte di massa. Era anche la vicenda più violenta, perché rivelava come la secolarizzazione presentasse un volto che smentiva quelle culture che l’avevano identificata con l’affermarsi del Progresso, la diffusione del benessere ecc. Quella scoppiata nell’agosto del 1914 era, insomma, la guerra della secolarizzazione e di un disincanto del mondo che si presentava nella sua forma così violenta da decretare la crisi di alcune convinzioni religiose tradizionali.
Allora, nella situazione di violenza in cui si era entrati a contatto con la morte di massa e la sofferenza, in che cosa credere, se la presenza del divino era evaporata e se la secolarizzazione si presentava in quella forma così distruttiva? Ancora Jünger per tutti: “I pericoli vissuti avevano sconvolto quella parte oscura dello spirito posta oltre la coscienza, in modo così profondo, che ogni rottura dell’ordine abituale delle cose faceva affacciare la morte come al finestrino di quegli orologi dai quali, custode e ammonitrice, essa si mostra ad ogni ora, al di sopra del quadrante, con la sua clessidra e la sua falce” (ivi, p. 14); e poi ancora, “la morte batteva le trincee con la sua mazza di ferro” (ivi, p. 74).
3. Le due religioni politiche: nazionalismo, internazionalismo, la politicizzazione integrale della vita
A ben guardare, se nella situazione provocata dalla Grande Guerra si esperiva la morte, o comunque il ritrarsi del divino dal mondo, tuttavia, non per questo si trattava di una situazione storica in cui si era verificato l’avvento del nichilismo vaticinato da Nietzsche. Infatti, il tracollo dei valori tradizionali aveva lasciato spazio alla presenza di altri valori o comunque a convinzioni forti, capaci di trovare udienza politica nelle masse. Gli uomini segnati dalla vita drammatica delle trincee erano emersi da quella vicenda avendo acquisito altre convinzioni, tutte ormai connesse a una visione secolarizzata e politicizzata della vita.
Due valori politici su tutti erano lievitati nel corso della guerra; e ambedue tradivano la matrice della secolarizzazione, nel senso che intrattenevano un rapporto molto stretto con l’avvenuto disincanto del mondo.
Intanto si era sviluppato e rafforzato il senso di appartenenza nazionale, ossia un nazionalismo che domandava agli uomini persino la disponibilità a sacrificare la vita per la patria.
Era poi lievitato il mito, esattamente contrario, di una rivoluzione sociale che avrebbe finalmente bandito la guerra dalla storia, abbattendo il capitalismo e persino le frontiere nazionali. Questo mito era stato, ad esempio, teorizzato da Lev Trockj, appena divenuto Commissario del popolo agli esteri nei primi giorni della rivoluzione bolscevica nell’ottobre 1917. Quel mito costituiva uno dei principali presupposti teorico-politici che avevano condotto Lenin e i bolscevichi a promuovere la rottura rivoluzionaria. Questa rottura avrebbe dato inizio alla trasformazione della guerra imperialistica in una guerra civile mondiale che avrebbe distrutto il capitalismo, eliminando la causa principale delle guerre fra i popoli. Per ora rimaniamo al nazionalismo.
Fino all’agosto 1914, il nazionalismo era stato una cultura politica coltivata dalle avanguardie intellettuali, sol che si pensi al caso italiano dei futuristi e dell’Associazione Nazionalista Italiana, una struttura politica che radunava giornalisti, scrittori, giuristi, storici ecc., ma senza alcun seguito di massa. Simile a quello italiano, anche se formatosi nel decennio precedente, era il nazionalismo francese, caratterizzato dall’egemonia politico-culturale di Charles Maurras e del movimento da lui promosso negli anni precedenti, l’Action française, un movimento che fin dagli inizi aveva attirato l’attenzione di alcuni ambienti intellettuali, compresi gli studenti universitari, ma che non era radicato nella società francese. Non è da escludere che l’entusiasmo di massa – la cosiddetta “comunità di agosto” – con cui furono accolte le dichiarazioni di guerra dovette sorprendere i gruppi nazionalisti dei vari Paesi, probabilmente meravigliati per quelle manifestazioni di giubilo; evidentemente, il precedente processo di nazionalizzazione delle masse aveva scavato in profondità, producendo un nazionalismo ben più diffuso dei nazionalismi politicamente organizzati fino ad allora presenti sul mercato politico-culturale.
In ambito storiografico è stato già rilevato che intellettuali fino ad allora chiusi nelle loro biblioteche ed estranei ai furori nazionalisti, nell’agosto 1914 tradivano “accenti mistici”, come nel caso di Edmund Husserl (cfr., Losurdo, 1991, p. 5), per non dire delle posizioni di Max Weber e Thomas Mann. Erano i medesimi accenti mistici che in precedenza avevano indotto proprio il teorico nazionalista francese Maurras a scrivere che “è bello morire per l’idea alla quale si aderisce (l’idée à laquelle on se donne)” (Maurras, 1914).
Due considerazioni s’impongono. La prima è che, rispetto all’idea dell’internazionalismo proletario, una posizione che rimontava a poco più di un cinquantennio, l’idea di “nazione” si era affermata almeno un secolo prima, nel corso della Rivoluzione francese. A titolo di puro esempio, era stato Desmoulins a definire il patriottismo quale “nuova religione che sta conquistando l’universo” (Desmoulins cit. in Soboul 1982, p. 175). Ciò significava che nel 1914 il nazionalismo aveva ormai una solida tradizione cui richiamarsi.
La seconda considerazione è che il nazionalismo che aveva mobilitato le folle europee nell’agosto 1914 costituiva una ripresa dell’idea di “nazione” diffusasi nel corso della Rivoluzione francese, sia perché assegnava alla nazione medesima un compito di natura culturale ed extrastatuale, nel senso che ci si mobilitava in nome della difesa di valori non immediatamente politici, quali, ad esempio, la difesa della Kultur per i tedeschi e la difesa dei popoli e della cultura slavi per l’impero zarista, sia perché l’idea di membro della nazione era militarizzata: si poteva godere della qualifica di membro della nazione solo in quanto si appoggiava lo sforzo bellico di quest’ultima.
Quanto all’altra idea, quella di una rivoluzione proletaria che, in nome dei valori dell’internazionalismo, avrebbe aperto all’umanità l’epoca della pace universale, essa era stata sconfitta nell’estate del 1914, con un’Interna-zionale socialista dissoltasi per la scelta di pressoché tutti i partiti socialisti europei di condividere la prospettiva della guerra voluta dai rispettivi governi. Fedeli ai valori dell’internazionalismo erano rimasti pochi partiti, fra i quali il Psi, e gruppi minoritari sparsi in Europa e senza alcun seguito e udienza di massa significativa. In una lettera del 24 ottobre 1914 al suo corrispondente italiano Agostino Lanzillo, sindacalista rivoluzionario schieratosi su posizioni interventiste, Georges Sorel scriveva di appartenere a una generazione di intellettuali “che non è più tra le correnti attuali; il socialismo di cui avevo fatto il centro dei miei studi, è allo stato attuale vecchio quanto la scolastica e Marx sarà per i giovani un personaggio illustre ma sconosciuto, un Duns Scoto o Raimondo Lullo” (Sorel in Germinario 1995, p. 209).
La prospettiva della rivoluzione proletaria, data per definitivamente in crisi nell’estate del 1914, sarebbe rinata tre anni dopo con la rivoluzione bolscevica, le cui parole d’ordine, a cominciare da quella di una pace immediata, si sarebbero presto diffuse in Europa, soprattutto nelle classi subalterne, trovando un’eco significativa anche nei combattenti nelle trincee.
Su queste due convinzioni maturate nel corso del conflitto – quella che si richiamava al nazionalismo e quella che investiva le sue energie sulla rivoluzione proletaria di respiro mondiale – potevano essere poste le basi solide delle successive religioni politiche dei regimi totalitari.
Ma non è sufficiente constatare che le sofferenze della Grande Guerra avevano diffuso la sensazione quanto meno dell’estraneità del divino dal mondo, perché si può rilevare almeno un altro aspetto che giustifica l’ipotesi della guerra quale sede d’origine delle religioni politiche.
Il rapporto fra la Grande Guerra e le future religioni politiche è dato dal fatto che con la guerra la politica era entrata di prepotenza nella vita di milioni di uomini che fino ad allora col mondo politico non avevano avuto rapporti ovvero li avevano avuti in maniera saltuaria. La guerra aveva proceduto a politicizzare la vita degli uomini, predisponendoli a condividere due posizioni politiche, nazionalismo e internazionalismo, che domandavano agli aderenti un impegno totalizzante. Con la guerra si era dilatata la tendenza pensare la vita come un percorso verso la morte – qualora volessimo riferirci al suggestivo concetto heideggeriano di vivere per la morte –, d’altro canto, essa era ripensata come una politisierte Leben.
Ritorneremo sul tema della guerra quale vicende che aveva avviato la politicizzazione integrale della vita. Per ora rimaniamo al tema del nazionalismo. Nel 1923 Carl Schmitt, riflettendo sulla teoria del mito politico elaborata da Georges Sorel nel 1908 e sull’elogio soreliano nel 1919 della figura di Lenin, paragonata a quella di Pietro il grande, osservava che
l’uso proletario della violenza ha reso la Russia di nuovo moscovita. Nella bocca di un marxista internazionale [Sorel] questa è una lode singolare, poiché essa dimostra che l’energia del principio nazionale è più grande di quella del mito della lotta di classe. Anche gli altri esempi di miti, che Sorel ricorda, nella misura in cui essi cadono in epoca recente, dimostrano la superiorità del principio nazionale (Schmitt 2007, p. 23).
Tre anni dopo, ritornando sul tema, il giurista tedesco osservava che, come stava dimostrando la vicenda dell’avvento del regime fascista in Italia, “il mito più potente è quello nazionalistico. […] Laddove si è giunti a una aperta opposizione fra i due miti – come in Italia – è il mito nazionale che finora ha trionfato“(Id., 1926, pp. 78-9). La vittoria del fascismo sul socialismo rivelava, a parere di Schmitt, “la forza irrazionale del mito nazionalista” (ivi, p. 79).
4. Nazionalismo postbellico e figura del nemico interno
Rimaniamo al tema che c’interessa, trascurando le pur interessanti riflessioni dello Schmitt interprete della teoria soreliana del mito politico, e limitandoci a rilevare che il giurista tedesco, individuando le due posizioni che si stavano affrontando in parecchie società del panorama politico europeo, registrava che il mito della nazione arrivava a prevalere su quello dell’internazionalismo e del socialismo: una convinzione escludeva l’altra.
Già Mosse aveva osservato che il nazionalismo era stato l’ideologia più diffusa, almeno nel Novecento e che esso “forniva un passato a coloro che avevano paura del presente” (Mosse 1988, p. 5). Sulla scia del giudizio di Mosse, conviene quanto meno distinguere i nazionalismi prebellici da quelli postbellici.
Almeno limitatamente agli anni del dopoguerra, viene da osservare che l’offerta politica e ideale nazionalista esasperava il senso dell’appartenenza nazionale, diffusa negli anni della guerra sia tra i soldati mobilitati sia nel fronte interno. Mentre nel periodo prebellico la dialettica politica nei sistemi politici liberali riusciva ad “assorbire” le posizioni nazionaliste, nel dopoguerra i nazionalismi, a causa della loro radicalizzazione, si presentavano su posizioni antisistemiche ed ostili alla cultura politica liberale.
Abbiamo già osservato come i nazionalismi che avevano caratterizzato la “comunità di agosto” presentavano alcune differenze rispetto ai nazionalismi dei decenni precedenti. È il caso di riprendere il tema. Il nazionalismo offriva un’identità più solida nonché socialmente trasversale, a fronte di un internazionalismo che, oltre ad essere limitato alle classi subalterne, scontava divisioni e rivalità politiche, quelle fra socialisti e comunisti, difficilmente ricomponibili. Anche se la formazione delle culture politiche e dei movimenti nazionalisti rimontava ai decenni precedenti lo scoppio della guerra, è anche verosimile che i movimenti nazionalisti dell’immediato dopoguerra, soprattutto nelle nazioni che erano uscite traumatizzate da quella vicenda, come Germania e Italia, avevano radicalizzato la loro azione politica: il timore dell’estensione del bolscevismo in Occidente si traduceva, nelle culture politiche nazionaliste, nella convinzione che i sistemi politici liberali risultavano troppo deboli per contrastare i progetti rivoluzionari bolscevichi. Il fervore nazionalista che aveva caratterizzato la “comunità di agosto” poteva ancora mediarsi con la tradizione liberale perché non presentava particolari istanze antisistemiche. Le masse che avevano salutato l’ingresso in guerra della propria nazione non potevano certo assumere posizioni ostili nei confronti di sistemi politici retti da classi dirigenti che avevano preso la decisione di partecipare alla guerra. Questa osservazione può valere persino nel caso italiano, dove pure il fronte interventista era schierato contro la classe dirigente, in gran parte scettica sulla partecipazione dell’Italia alla guerra, piuttosto che contro il sistema politico liberale.
Se fino al 1914 il nazionalismo si era spesso caratterizzato per posizioni espansionistiche, e dunque per una maggiore attenzione alla politica estera rispetto a quella interna, nel dopoguerra si verificava un rovesciamento di questo rapporto gerarchico per l’inasprimento dello scontro di classe interno, visto come una minaccia per la sopravvivenza della società, prima che per le istituzioni. Mentre negli anni precedenti lo scoppio della guerra i movimenti nazionalisti – tranne che nel caso francese, per motivi che non è questa l’occasione di discutere – avevano agito spesso da stimolo per una politica estera espansionistica da parte degli Stati liberali, i movimenti nazionalisti del dopoguerra si presentavano come opposizioni antisistemiche, intendendo salvaguardare la società, anzi la medesima civiltà europea, rivelando la loro ostilità nei confronti dello Stato liberale, ritenuto troppo debole per contrastare le spinte rivoluzionarie provenienti dalla sinistra.
La spinta alla radicalizzazione politica delle culture politiche nazionaliste del dopoguerra era accelerata dal timore del nemico interno: questa figura prevaleva sul timore del nemico esterno, non foss’altro perché questo lo si era già affrontato in una guerra durata più di quattro anni. Il liberalismo era interpretato quale ideologia e pratica di governo adatte nelle situazioni storiche in cui la dialettica politica si ispirava a principi di normalità. Ma la dialettica politica liberale non poteva valere nelle situazioni ritenuti eccezionali, come quella del dopoguerra, in cui il nemico esterno, la Russia dei soviet, si saldava con l’azione rivoluzionaria del nemico interno, i gruppi e i partiti che, nei singoli Stati, ispiravano la loro pratica politica al bolscevismo.
Del resto, nelle ideologie rivoluzionarie, soprattutto in quelle che si richiamavano a uno statuto teorico nazionalista, la figura del nemico interno era ritenuta ben più pericolosa di quella del nemico esterno, perché procedeva all’opera subdola di sgretolare la società senza rivelarsi: su questo punto, aveva fatto scuola la già fiorente tradizione teorico-politica antisemita, a muovere quanto meno dall’Affaire Dreyfus.
Una delle cause del successo editoriale che nel dopoguerra avrebbero riscosso le diverse traduzioni nelle principali lingue europee dei Protocolli degli Anziani Savi di Sion, la cui circolazione era stata fino ad allora limitata alla Russia zarista, è da rintracciare nell’evocazione della pericolosità della figura del nemico interno rispetto a quello esterno. Nella memorialistica di guerra, da Ernst Jünger a Pierre Drieu La Rochelle, è corrente il giudizio sul rispetto dovuto al nemico: questi vestiva un’altra divisa, rivelando con quella scelta la fedeltà alla propria nazione. “Quelli che combatto non li odio”, aveva confessato il poeta irlandese William Yeats (Yeats in Amerio e Ottieri 2014, p. 45). Il nemico interno era invece ritenuto più pericoloso sia perché agiva lentamente contro gli interessi della nazione, godendo dei medesimi diritti di coloro che alla nazione erano fedeli e si ergevano a difensori di essa, sia perché la condizione di inimicizia si rivelava in un atteggiamento ideologico che negava addirittura, soprattutto nel caso delle varie posizioni internazionaliste, il senso di appartenenza nazionale. Se il nemico esterno, almeno in guerra, era stato meritevole di rispetto, contro quello interno non erano possibili le mediazioni: era da eliminare. Questa soluzione, prima che si affermasse, soprattutto nella seconda metà degli anni Trenta, in seguito alle efferatezze del comunismo staliniano, aveva trovato nello squadrismo fascista prima e nel nazismo poi i suoi momenti di verifica.
Ora, la prevalenza della figura del nemico interno su quello esterno può essere ritenuta uno degli aspetti più significativi della crisi della dialettica politica nella società, in quanto acuiva lo scontro fra gli schieramenti politici, perché soprattutto le posizioni nazionaliste delegittimavano l’avversario. La lotta contro il nemico interno costituiva una logica politica che minava il funzionamento delle istituzioni dello Stato liberale.
Non era questo l’unico frangente della storia europea in cui era prevalso il timore del nemico interno: il Terrore montagnardo del 1793-94 si era sviluppato proprio nel rispetto di questa feroce quanto implacabile logica cospirazionista. Ma proprio questa comparazione rendeva palese la situazione di crisi in cui erano precipitate diverse nazioni europee: una crisi che si traduceva nella constatazione che, se la guerra era ufficialmente terminata nel novembre del 1918, permanevano ancora diversi focolai bellici, soprattutto nell’Europa dell’Est, o comunque scontri politico-ideologici interni che rischiavano di precipitare in rotture rivoluzionarie sull’esempio del caso russo. Ma è il caso di tornare a Schmitt.
5. La rivoluzione quale punto alto della secolarizzazione e la differenza fra la visione di sinistra e quella di destra in materia di rivoluzione
Carl Schmitt parlava di miti politici, avendo assunto come interlocutore ideale Sorel. Ad avviso di Schmitt, come s’è visto, il filosofo francese sottovalutava che, accanto ai miti della nazione e della rivoluzione proletaria, si stavano rapidamente coagulando mentalità e sensibilità che ridefinivano l’azione politica secondo uno statuto prossimo alla religione.
C’è un aspetto teorico-politico da rilevare. In prima istanza, sia le posizioni nazionaliste sia quelle internazionaliste erano rivoluzionarie certamente in forza della convinzione che il liberalismo era ritenuto inadeguato a risolvere i problemi sociali.
Tuttavia, il loro carattere rivoluzionario era il risultato della registrazione che la guerra, sconvolgendo la vita umana prima che gli Stati e i sistemi politici, aveva dimostrato l’autosufficienza dell’uomo nel determinare la storia. Le posizioni rivoluzionarie di destra come di sinistra si pensavano come un momento di rottura, una specie di balzo poderoso della storia; esse si presentavano come un programma di salvezza dell’umanità – questo aspetto era soprattutto più evidente nelle posizioni di sinistra –, prescindendo dalla provvidenza divina.
Anzi, le posizioni rivoluzionarie hanno sempre costituito una critica della provvidenza divina, reputata inesistente. Si possono intendere le rivoluzioni come il punto più alto dell’avvenuta secolarizzazione, in quanto gli uomini avvertono di essere autosufficienti nella loro prassi, senza che intervengano soggetti di natura trascendentale. In questo senso, la rivoluzione era l’atto più immanente – diremmo quasi pagano – che potesse verificarsi.
Ora, dove passava la differenza culturale fra i progetti rivoluzionari di destra e quelli di sinistra? Solo nella contrapposizione fra la soluzione nazionalista e quella internazionalista?
La differenza la individueremmo nell’atteggiamento differente davanti all’idea di Progresso.
Si è già osservato come la visione illuministica e liberale che identificava la storia come affermazione del Pro-gresso non riscuotesse più credibilità nella cultura dell’epoca già dai decenni prima della guerra. Si potrebbe aggiungere che la guerra era vocata a essere valorizzata dalle destre nazionaliste, piuttosto che dalle sinistre, non foss’altro perché costituiva una smentita dell’internazionalismo proletario. Ma non basta.
Tutta la cultura politica di sinistra, da quella di orientamento riformista a quella che più insisteva sulla prospettiva della rottura rivoluzionaria, era convinta che l’idea di Progresso fosse il motore della storia e che quest’ultima, di conseguenza, presentasse un percorso ascendente, vanamente contrastato da quelle forze reazionarie e conservatrici che si opponevano senza successo a quel processo storico ritenuto inevitabile: la cultura di sinistra reputava che queste forze fossero al di fuori del moto della storia. Lo stesso bolscevismo aveva giustificato la scelta della rottura rivoluzionaria nell’ottobre 1917 presentandola quale soluzione del tutto interna all’oggettività del processo storico – un processo che prevedeva appunto un futuro socialista – e giudicando i suoi oppositori, socialisti riformisti compresi, attardati su posizioni oscurantiste e appunto al di fuori della tendenza della storia.
Ostili alla visione liberale del Progresso, i bolscevichi pensavano che l’unico Progresso possibile consistesse nella rivoluzione proletaria. Per l’altro verso, negavano che quel corso fosse identificabile con l’affermarsi del Progresso. In sede storiografica si è quasi sempre trascurato che ciò che ha caratterizzato la destra nazionalrivoluzionaria del Novecento è che essa, al contrario di una sinistra dotata di una filosofia della storia ereditata dai Lumi prima che da Hegel, è sempre stata priva di una filosofia della storia, ossia della convinzione che questa rivelasse un percorso predefinito. Questa mancanza ha permesso alla destra nazionalrivoluzionaria di immaginare la storia come un percorso aperto a soluzioni differenti, tutte dipendenti dalle scelte e dalla prassi degli uomini.
È da avanzare l’ipotesi storiografica che questa visione “aperta” della storia abbia contribuito in maniera determinante ai successi della destra nazionalrivoluzionaria sul mercato politico e delle idee, intercettando e valorizzando la domanda diffusa in vasti settori della società europea di una partecipazione in prima persona ai processi storici e politici. Se fino allo scoppio della guerra vasti settori della società avvertivano di subire la storia ovvero, come nel caso dei ceti medi, avevano delegato le decisioni politiche alla borghesia, la visione “aperta” della storia proposta dalla destra nazionalrivoluzionaria offriva a questi settori i motivi per esercitare un protagonismo che li proiettava sul teatro della storia.
Ora, nell’opposizione della destra nazionalrivoluzionaria all’ideologia del Progresso intanto agiva l’ostilità nei confronti della cultura dei Lumi, messa sotto accusa, nel periodo precedente la guerra, dall’offensiva promossa da Nietzsche e da Croce, da Pareto come da Sorel. La cultura europea prebellica, almeno nei suoi autori più rappresentativi, non era stata altro che un articolato quanto insistente atto d’accusa nei confronti dei Lumi e dell’ideologia del Progresso.
Il panorama creato dalla guerra era stato vissuto come una conferma di quelle critiche: la morte di massa e le sofferenze patite dagli uomini avevano dimostrato che il Presente, celebrato dalla cultura liberale quale epoca della pace, del Progresso e della prosperità, non corrispondeva a quella visione della storia. Anche se la maggioranza degli Stati che avevano partecipato alla guerra erano Stati liberali – sia pure con gradazioni differenti, che procedevano da un liberalismo con venature autoritarie (la Germania guglielmina) ad uno politicamente molto avanzato (la Francia della Terza Repubblica) –, la guerra si era rivelata una situazione che aveva smentito clamorosamente alcuni degli aspetti più significativi dell’universo ideologico del liberalismo, come appunto la convinzione che la spinta al Progresso orientasse la storia umana. Inoltre, a una sinistra rivoluzionaria, dotata delle sicurezze assicuratele da una filosofia ottimistica della storia, la destra nazionalrivoluzionaria opponeva una visione della storia la cui cupezza risultava comunque emancipata dalla scelta di ricorrere a una prassi che riusciva a orientare il corso della storia medesima: questa non aveva fini predefiniti, al di là di quelli che le assegnava lo sforzo umano.
Il problema storiografico possiamo così delinearlo: in che senso queste due convinzioni erano suscettibili di fondare le successive religioni politiche degli Stati totalitari? In virtù di quali motivi il conflitto bellico aveva prodotto quel processo che riformulava la politica, assegnandole uno statuto religioso?
Se la guerra era stata vissuta come momento culminante della secolarizzazione, in quanto vicenda che aveva allontanato il divino dal mondo e dalla storia, questo risultato reperiva il suo fondamento non solo nella registrazione che la morte di massa e le sofferenze rivelavano l’indifferenza divina nei confronti delle vicende umane. Un altro risultato di come era stata vissuta e rielaborata la vicenda bellica era consistito nella maturazione della convinzione dell’onnipotenza umana: la guerra aveva dimostrato che l’uomo si riconosceva il potere di sconvolgere la storia, ricorrendo alla violenza e alla guerra, per accelerare processi storici peraltro non previsti dalle precedenti filosofie della storia presenti sul mercato delle idee, a cominciare dalla convinzione giudaico-cristiana sulla presenza del divino nel mondo per finire al liberalismo. Se l’uomo, come aveva dimostrato la gigantesca quanto sconvolgente vicenda della guerra, era in grado di dominare la storia, e addirittura di imprimere un ritmo accelerato e tumultuoso ai processi storici, diveniva superflua la convinzione della presenza del divino nel mondo.
A questo punto, la politica era nelle condizioni di sostituire la religione: avendo, la guerra, per un verso, trasmesso la suggestione dell’onnipotenza della prassi umana e, per l’altro verso, prodotto quale risultato una politicizzazione integrale della vita umana, la politica poteva fornire le risposte che la religione non era più in grado di elaborare.
 https://www.asterios.it/catalogo/totalitarismo-movimento
https://www.asterios.it/catalogo/totalitarismo-movimento