Di evidente matrice religiosa, il tema della fine del mondo non è mai totalmente scomparso nella riflessione filosofica, a dispetto di ogni secolarizzazione. È un tema che fa capolino, ovviamente, soprattutto in periodi di crisi particolarmente acute, coinvolgendo un ampio spettro di atteggiamenti mentali e registri di analisi, dalla semplice superstizione alla sofisticata analisi scientifica, filosofica e politica[1]. Tale atteggiamento può essere considerato il sintomo di una crisi di civiltà, che avverte di vacillare di fronte alle sfide di un presente minaccioso, la cui pericolosità fa sorgere sentimenti di panico che si focalizzano nella prefigurazione di una fine catastrofica. A partire dal 1945, tale discorso ha trovato nuovo vigore dal riscontro fattuale dei crimini senza precedenti della Seconda Guerra mondiale e dall’esplosione delle prime bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, che insinuano l’idea di una lacerazione più profonda di quelle che hanno sempre attraversato la storia politica, arrivando a mettere in discussione il legame stesso tra l’uomo e il mondo. Da quel momento la «fine del mondo» cessava di essere il fantasma di qualche setta apocalittica, per approssimarsi ad una categoria dell’esperienza dotata di evidenza empirica: l’energia atomica, anche quando non è più utilizzata come arma militare, resta pur sempre una minaccia che pone l’umanità di fronte alla prospettiva del nulla.
Günther Anders è stato sicuramente il filosofo che più di altri ha contribuito a riattivare lo schema apocalittico nell’ambito del pensiero contemporaneo, a partire da una constatazione di fatto per lui irrinunciabile: «Noi viviamo ormai in una umanità per la quale il “mondo” e l’esperienza del mondo hanno perso ogni valore».[2] Il suo pensiero ha sempre ruotato intorno alla «Bomba» e alla possibile fine del tempo, visto soprattutto sotto la categoria del «termine» [Frist], conquistandosi il merito di definire per primo la novità sconvolgente costituita dal lancio della bomba atomica, con tutte le conseguenze riguardo alla definizione stessa di umanità nell’epoca della sua distruzione come minaccia incombente[3]. Il primo volume di L’uomo è antiquato compare undici anni dopo il 6 agosto 1945 e si presenta come un’opera di forte originalità su tematiche allora inedite nel dibattito intellettuale. Nell’affrontare il problema della bomba atomica, Anders avvertiva innanzitutto il problema della difficoltà linguistica. Non esiste, in realtà, una parola adeguata per descrivere la realtà concettuale intesa dal termine dall’evocazione terrificante “la Bomba”, di cui è solo possibile evocarne la forza distruttiva. Quello su cui Anders insiste, invece, è l’incitamento adQue opporsi al desiderio generalizzato di rimozione. Proprio perché il discorso sulla bomba tende alla banalizzazione, diventa impellente il ricorso all’“esagerazione” come scuotimento dell’ottundimento della coscienza.[4] Essendo l’invenzione nucleare l’esito più angosciante della tecnicizzazione del reale, occorre far di tutto per farne saltare gli automatismi che porterebbe inevitabilmente al suo utilizzo.
 https://www.asterios.it/catalogo/brevi-scritti-sulla-fine-delluomo
https://www.asterios.it/catalogo/brevi-scritti-sulla-fine-delluomo
1. La logica del catastrofismo
Puntare ossessivamente l’attenzione sulla ineluttabilità della catastrofe, era un modo per Anders di svegliare le coscienze, riattivando quelle risorse etiche e politiche necessarie per contrastare l’anestetizzazione morale della società contemporanea. Proprio in quanto portatore di un’esigenza di riforma della ragione umana, la posizione di Anders ha trovato recentemente una valorizzazione critica nel filosofo ed epistemologo francese Jean-Pierre Dupuy, autore nel 2002 di Pour un catastrophisme eclairé,[5] nel quale, indipendentemente da Anders – che allora non conosceva – proponeva di reagire alle sfide globali che minacciano gli equilibri della vita sul pianeta attraverso l’assunzione della catastrofe come il destino della nostra epoca. Anche Dupuy, infatti, ritiene che la prossimità del nostro presente all’apocalissi richieda un soprassalto concettuale che rompa con le consuete abitudini di pensiero. Lo scarto tra ciò che l’umanità può fare e i mezzi teorici di cui dispone per comprendere il suo potere non è mai stato così grande: «Abbiamo acquisito i mezzi per distruggere il pianeta, ma non abbiamo cambiato il nostro modo di pensarlo».[6]
La consapevolezza della catastrofe implicherebbe di rovesciare la gerarchia degli atteggiamenti nei confronti del mondo, privilegiando la certezza (del peggio) sul dubbio. Di conseguenza, la catastrofe andrebbe pensata come un fenomeno d’ordine modale che spinge a considerare l’impossibile come necessario per meglio lottare contro di esso. Facendo della catastrofe un destino, ci si dà in anticipo i mezzi per credere in ciò che sappiamo: la distruzione assoluta costituisce ormai e per sempre una componente essenziale dell’agire umano. Dal momento che lo si considera certo, il futuro agisce già sul presente, introducendo lo scenario del peggio nella decisione.
Oltre Anders, Dupuy si richiama ad Hannah Arendt, pensatrice che ha saputo cogliere la condizione tragica di uno sviluppo tecnologico che non solo si sottrae al controllo etico dell’uomo, ma minaccia di renderlo superfluo. È il nodo problematico che Anders individuava nel «dislivello prometeico» e che in Arendt si riassumeva nella thoughtlessness, l’incapacità di render conto di quello che abbiamo creato in un discorso che dia senso al nostro stare al mondo.[7]Tale incapacità di padroneggiare ciò che si è in grado di fare deriva proprio dal procedere della scienza e della tecnica moderna, che non si limitano più ad una «esplorazione delle leggi naturali e alla fabbricazione di oggetti mediante materiali offerti dalla natura», ma tendono a «creare processi “naturali” che senza gli uomini non sarebbero mai esistiti, e che la natura terrestre sembra incapace di compiere da se stessa.[…] In questo tipo di azione […] si sono avviati processi dei quali non è dato prevedere l’esito, così che l’incertezza, anziché la fragilità, diventa il carattere decisivo delle cose umane».[8]
L’intuizione di Arendt sull’incapacità di controllare a pieno gli effetti del potere scientifico e tecnologico pone in maniera originale il rapporto tra quello che gli uomini possono fare e il riconoscimento di ciò che è dato. Secondo Arendt, infatti, nell’evoluzione della scienza moderna risulta decisiva l’acquisizione, da parte degli uomini, della capacità di intervenire all’interno della natura come se ne disponessero dall’esterno. Potendo produrre elementi mai trovati in natura, l’uomo dimostra un nuovo potere “creativo”, quello che in passato si considerava una prerogativa divina. Si tratta di un passaggio argomentativo che Arendt condivide in tutto con Anders, il quale, in un passo del secondo volume di L’uomo è antiquato, individua il punto culminante della contemporaneità nel passaggio dall’homo faber, simbolo del fare prometeico della modernità, all’homo creator, capace di spingere la potenza tecnico-operativa ben dentro i processi della natura e della vita: «con la denominazionehomo creator intendo il fatto che noi siamo capaci, o meglio, che ci siamo resi capaci, di generare prodotti dalla natura, che non fanno parte (come la casa costruita con il legno) della categoria dei “prodotti culturali”, ma della natura stessa ».[9] Potenziato dallo sviluppo illimitato della tecnica, l’uomo non si limita più a trasformare la natura, ma ha acquisito la capacità, appunto, di creare la natura, di introdurre sulla scena prodotti e processi del tutto «nuovi» (dal plutonio, alla bomba nucleare, alle manipolazioni genetiche), alterando profondamente le leggi stesse dell’evoluzione e aprendo orizzonti del tutto imprevedibili. Il problema non è il sovvertimento del limite tra natura e artificio, la commistione di techne e physis, perché è proprio della natura umana, in base agli assunti antropologici comuni a Arendt e a Anders, quello di «non avere una natura», di essere caratterizzata da un’indeterminatezza costitutiva che la spinge a ricreare continuamente il proprio equilibrio con l’ambiente naturale, modificandolo e relazionandosi ad esso in forme sempre nuove e diverse.[10] Ma è proprio questo fragile equilibrio tra ciò che è dato e la capacità trasformativa degli uomini, tra una cornice ritenuta immutabile che dava senso e orientamento al mondo e la libertà umana di costruire un proprio equilibrio al suo interno, che si spezza con l’irrompere della tecnica moderna, arrivando a produrre quelle patologie della modernità, che per Arendt e Anders si possono racchiudere nella categoria di «perdita del mondo».[11] Il punto di svolta è la «ribellione contro l’esistenza umana così come gli è stata data, un dono gratuito […] che desidera scambiare, se possibile, con qualcosa che lui stesso abbia fatto».[12]
La hybris che muove l’uomo moderno rimanda quindi ad una volontà di potenza che si prefigge il dominio sulle condizioni stesse della vita. Si tratta, però, di un dominio che, proprio nel suo culmine, è soggetto a rovesciarsi nel suo contrario, in un sentimento di frustrazione rispetto al mondo degli oggetti artificialmente costruiti, che appare adesso dotato di tutte quelle qualità di cui l’uomo, quale corpo organico e materia vivente, si sente ormai sprovvisto. È questo un altro punto su cui la riflessione di Arendt converge in maniera puntuale con quella di Anders, il quale sottolinea la tendenza degli uomini a «identificarsi» col mondo dei prodotti e delle macchine. Tuttavia, proprio in virtù della superiorità tecnica del mondo delle macchine, si innesta negli uomini, secondo Anders, un sentimento di profondo disagio che egli definisce come «vergogna prometeica», cioè il rifiuto della propria dimensione organica di fronte alla perfezione del mondo fabbricato. È vero che il sentimento di vergogna, come Anders aveva già annotato in alcune riflessioni antropologiche degli anni trenta,[13] è connaturato alla libertà dell’uomo, in quanto esprime il disagio di sentirsi gettato nel mondo, estraneo ad esso e, quindi, obbligato a fare i conti con la propria contingenza, in un equilibrio sempre precario ma necessario, tra ciò che è dato e ciò che l’uomo riesce a fare da sé. Col rischio che l’uomo tratti non solo il mondo come «materia prima»[14] da utilizzare e sfruttare ai propri fini secondo quella logica strumentale che attribuisce realtà solo a ciò che è utilizzabile, ma che tratti come tale anche se stesso; e da homo creator si riduca così a homo materia.[15] Ma la hybris prometeica dell’uomo non si rovescia solo nella perdita della libertà per aderire ad un ideale di perfezione che non ha niente di umano. All’orizzonte vi è anche lo spettro dell’autodistruzione evocato dall’atto nichilistico estremo che è la creazione della bomba nucleare, il segno beffardo del capovolgimento del potere in impotenza e della definitiva inversione del rapporto mezzi-fini. Lo scollamento tra la capacità di produrre e quella di prevederne gli effetti raggiunge qui il suo culmine, mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa dell’umanità sul pianeta e dando origine alla coesistenza paradossale di onnipotenza e vulnerabilità che caratterizza l’homo creator, e che apre il futuro del mondo a destini sempre più impensabili e inimmaginabili.
In questa interpretazione, Hiroshima rappresenta la cattiva coscienza della modernità. L’arma nucleare, creando un’energia che supera tutte quelle che il mondo potrebbe mai produrre da sé solo, segna l’apogeo del progetto moderno di mettere la natura sotto il dominio della tecnica. Ma si tratta di una vittoria di Pirro, poiché l’ambizione prometeica minaccia ad ogni istante di ritorcersi contro i suoi promotori. Mentre le antiche escatologie promettevano dei «regni senza apocalissi», perché consideravano la fine del mondo (cioè di quello esistente con le sue ingiustizie) soltanto come una tappa necessaria nel cammino della libertà, il presente dominato dal nucleare, per Anders, non promette nulla perché il suo orizzonte è quello di una «nuda apocalissi», senza regno e senza futuro.[16] «Se noi ci distinguiamo dagli apocalittici giudeo-cristiani classici non è soltanto perché noi temiamo la fine (che essi, invece, speravano) ma soprattutto perché la nostra passione apocalittica non ha altro obiettivo che quello di impedire l’apocalisse».[17] Contrariamente ai suoi precursori, l’apocalittico contemporaneo è animato dalla passione di avere torto. Annunciando che viviamo il «tempo della fine», egli vuole produrre un’angoscia che ponga gli uomini di fronte alla propria finitezza. È proprio perché il mondo può finire che vi è qualcosa da fare, utilizzando l’angoscia apocalittica per agire attivamente contro la catastrofe, a differenza del potere paralizzante della paura o della speranza delle istante apocalittiche tradizionali.
2. Messianismo e apocalissi
Da questo punto di vista, Anders si pone agli antipodi di chi, come Ernst Bloch,[18] ha preteso reinterpretare lo stesso marxismo alla luce della redenzione propria della tradizione ebraica. Viceversa, il rapporto di Anders con l’identità ebraica è molto più sfuggente non solo perché storicamente coincidente con una fase di declino della tradizione[19], ma anche perché tutta la sua riflessione filosofica ruota intorno alla indeterminatezza costitutiva dell’essere umano che non riesce mai a cogliere la propria essenza in un nucleo definito e stabile. Dell’essere ebreo, Anders sottolineava soprattutto lo «sradicamento», la «contingenza» e la «vergogna», che vengono a costituire una sorta di trasfigurazione filosofica dell’esperienza dell’uomo contemporaneo. Parlare di identità ebraica di Günther Anders è ammissibile soltanto se si intende con ciò la sua “non-identificazione”, il suo spirito di fuga che rappresenta una forma liberamente scelta e altamente selettiva di fedeltà. Tale orrore dell’assimilazione e delle connesse patologie, dà senso alla scelta dello pseudonimo, Anders, che deve essere inteso come colui che si sottrae ad ogni assimilazione, che non si adegua mai del tutto ad alcuna credenza.
Però, se consideriamo le annotazioni sparse e tutt’altro che sistematiche che Anders dedicò alla questione dell’ebraismo, notiamo che il retaggio ebraico gioca pur sempre un ruolo, risolvendosi in quel tono profetico che lo porta a farsi irretire lo sguardo dagli occhi di Medusa dell’Apocalissi nucleare, in cui il nichilismo dell’epoca moderna trova il suo compimento.[20] Senza un riferimento ad un ideale messianico, Anders non avrebbe, infatti, potuto interpretare il Novecento ponendolo sotto il segno della catastrofe irreversibile e senza ritorno. È lui stesso a sottolineare tale nesso, in un saggio del 1974 in cui, attraverso un semplice aneddoto, indicava la trama di fili che collegano Auschwitz e Hiroshima, lo sterminio degli ebrei e la minaccia di una distruzione totale dell’umanità.[21] Tutto ciò aveva a che fare con quell’intreccio di messianismo ebraico e messianismo rivoluzionario che aveva caratterizzato le cerchie culturali e politiche nelle quali Anders si era formato e si era mosso durante gli anni dell’emigrazione. Se la sua fede messianica non è sopravvissuta alle due grandi catastrofi e rotture della civiltà della modernità, Auschwitz e Hiroshima, ciò che continuava ad accostarlo a Ernst Bloch, molto più “ebreo” di lui sotto questo aspetto, era ancora la medesima valutazione dell’eredità ebraica, una sorta di patrimonio morale che permetteva di parlare degli ebrei come «sale della terra» e della loro forza profetica come del messaggio di redenzione universale dell’umanità. Quello che sopravvive è lo schema concettuale, rovesciato di segno, del messianismo ebraico.
La lezione del XX secolo comportava una novità sconvolgente: se nei campi di sterminio si era messa in atto un’uccisione industrializzata di massa, con le bombe all’uranio e all’idrogeno fa capolino una formulazione del tutto inedita: «L’umanità in quanto tale è uccidibile».[22] Per dare espressione a questa terribile situazione, Anders fa ricorso ad espressioni estremamente evocative dal punto di vista religioso e storico: quasi in maniera ossessiva egli parla di “apocalisse possibile”, di “pericolo apocalittico”, di “noi come signori dell’Apocalisse”, e già il titolo del suo saggio mette in guardia dalla “cecità all’Apocalisse”.[23] Si tratta di un tema gravido di implicazioni della tradizione giudaico-cristiana, svuotato però, quasi in senso parodistico, di ogni aspettativa messianica di rivelazione. Per quanto lontano stia tale concetto di apocalisse da un’interpretazione del presente dopo Auschwitz e Hiroshima, esso lascia presagire perché le visioni apocalittiche di una fine dei tempi siano comparse soprattutto in periodi di crisi e di rivolgimento. L’apocalisse ha sempre comportato un tratto rivoluzionario, assommava in sé un “potere distruttivo e uno propositivo”.[24] Il futuro non era per essa indeterminato, ma era percepito come vicino, si rispecchiava già nel presente. La fine implorata dall’odio apocalittico non doveva introdurre una mostruosa dannazione, ma la comparsa del Regno profetizzato. Secondo Anders, le catastrofi del Novecento svuotavano di senso il discorso dell’apocalisse, dell’escatologia, del chiliasmo o del messianismo, proprio perché allontanavano definitivamente la speranza del loro adempimento. Ad essere cieco di fronte all’Apocalisse è il presente dominato dalla assoluta insensatezza di un produrre tecnico che mette sullo stesso piano accrescimento della capacità produttiva e produzione di ordigni in grado di distruggere le condizioni stesse di vita sul pianeta.[25]
Il ricorso che Anders fa al concetto di apocalisse si lascia bene illuminare da alcune riflessioni che Ernesto De Martino compie in alcuni abbozzi preparatori alle analisi delle «apocalissi culturali» che avrebbero dovuto confluire ne La fine del mondo.[26]In queste pagine, Anders compare come uno degli interpreti più acuti della novità rappresentata dal pericolo atomico e degli effetti che esso comporta nella prefigurazione di una «catastrofe del mondano» che De Martino individuava come una cifra fondamentale della congiuntura culturale contemporanea. Si tratta di una «apocalisse senza escaton», proprio perché viene a mancare ogni orizzonte religioso di salvezza che storicamente aveva sempre plasmato il tema della fine del mondo. In contrasto con questa «riplasmazione religiosa, l’attuale congiuntura culturale conosce invece il tema della fine al di fuori di qualsiasi orizzonte religioso di salvezza, e cioè come nuda e disperata catastrofe del mondano, del domestico […]. Nella sua forma più vistosa, più esteriore e più tragicamente paradossale questa disposizione annientatrice trova il suo infausto coronamento nel terrore atomico della fine, cioè nella prospettata possibilità che l’umanità si autodistrugga mediante l’impiego antiumano della sua sapienza tecnica».[27]
Se è vero che in Anders è assente ogni prospettiva escatologica, come sottolinea convincentemente Werner Reimann,[28]ciò non vuol dire però che venga a cadere ogni riferimento alla prospettiva messianica. Anzi, è proprio tale anelito ad una redenzione costitutivamente frustrata dal dominio di una tecnica onnivora e potenzialmente distruttiva a dare il tono della critica andersiana al presente e a leggere in esso una tendenza catastrofica, un rovesciare di segno una filosofia del progresso che a quello stesso messianismo aveva attinto, attestandosi su un imperativo, disperato quanto necessario, di scongiurare l’inesorabile.
Note
[1]Per una critica ragionata e attenta del fenomeno, con un’attenzione sia al discorso pubblico che alla speculazione scientifica e filosofica, cfr. T. Pievani, La fine del mondo. Guida per apocalittici perplessi, Il Mulino, Bologna 2012 e M. Foessel, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Seuil, Paris 2012.
[2]G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, vol. II, C.H. Beck, München 1980; tr. it. L’uomo è antiquato. Vol. II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 243.
[3]Cfr. E. Pulcini, Distruttività e autoconservazione in età nucleare, in E. Pulcini, P. Messeri (a cura di), Immagini dell’impensabile. Ricerche interdisciplinari sulla guerra nucleare, Marietti,Genova 1991.
[4] L’esagerazione è quindi un programma etico-politico di Anders, che assume volutamente toni provocatori nella sua “filosofia d’occasione”. Cfr. G. Anders, Übertreibungen in Richtung Wahrheit, hrsg. von L. Lütkehaus, Beck, München 1994.
[5] J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Seuil, Paris 2002, tr. it. Per un catastrofismo illuminati: quando l’impossibile è certo, Medusa, Milano 2011. Epistemologo di formazione, Dupuy si è formato intellettualmente attraverso un sodalizio intellettuale prima con Ivan Illich e poi con René Girard, affermandosi nelle scienze sociali come un interprete critico del liberalismo politico e delle teorie dell’ordine spontaneo: cfr. Ordres et désordres, Seuil, Paris 1982; Le sacrifice et l’envie. Le liberalisme aux prises avec la justice sociale, Calmann-Levy, Paris 1992, tr. it. Il sacrificio e l’invidia. Liberalismo e giustizia sociale, Ecig, Genova 1997; Avions nous oublié le mal? Penser la politique après le 11 septembre, Bayard, Paris 2002; Dans l’oeil du cyclone, Carnets Nord, Paris 2008. Solo nel 2005 Dupuy si confronta col pensiero di Anders, in occasione di un viaggio a Chernobyl, Id., Retour de Tchernobyl. Journal d’un homme en colère, Seuil, Paris 2006, riconoscendone molte affinità e assumendolo come autore di riferimento: cfr. Petite Métaphysique des tsunamis, Seuil, Paris 2005, tr.it., Donzelli, Roma 2006.
[6]J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, cit., p. 15.
[7]H. Arendt, The Human Condition, University of Chicago, Chicago 1958, tr. it Vita activa, Bompiani, Milano 1983, p. 3. È questa la prima volta in cui compare la dicitura thoughtless, che in inglese si presenta come una forzatura, un calco dal tedesco denklos, coniugata ad un potenziale dell’apparato tecnologico molto elevato, con una combinazione dagli effetti micidiali [murderous]. La personalità del criminale di guerra Eichmann, che Arendt avrebbe analizzato tre anni dopo, seguendone a Gerusalemme il processo, si presenta come un tragico epifenomeno di questa difficoltà dell’uomo moderno di tener il passo, dal punto di vista emotivo, cognitivo ed etico, con la complessità e potenza dell’apparato tecnico e dell’organizzazione sociale. È quello che Anders chiamava il «dislivello prometeico» tra la capacità umana di realizzare dispositivi tecnici sempre più complessi e la capacità di immaginarne e prevederne gli effetti distruttivi. Criminali senza cattiveria e vittime non dell’odio, ma dello sterminio burocratico, sono anche per Anders i tratti dei disastri e delle tragedie della nostra contemporaneità, come avvenuto ad Auschwitz e a Hiroshima. Come si legge in G. Anders, Hiroshima ist überall, Beck, München 1982, p. 45, «la tecnologia ha comportato il fatto che tutti noi possiamo diventare colpevoli senza colpa.» J. P. Dupuy ha scritto anche un’importante prefazione, Günther Anders, le philosophe de l’âge atomique, all’edizione francese di questo testo, Hiroshima est partout, Seuil, Paris 2008, pp. 7-31, in cui, tra l’altro, sottolinea la vicinanza di pensiero tra Anders e Arendt, nonostante il tentativo di quest’ultima di minimizzarne la portata, più per questioni personali che per una effettiva distanza intellettuale.
[8]H. Arendt, Vita activa, cit., pp. 170-171.
[9]G. Anders, L’uomo è antiquato, cit., p. 15.
[10]Cfr. E. Pulcini, L’«homo creator» e la perdita del mondo, in M. Fimiani – V. Gessa Kurotschka (a cura di), Umano Post-Umano. Potere, sapere, etica nell’età globale, Editori Riuniti, Roma 2004, pp. 11-42; Id., La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
[11]Per una recente messa a punto perspicua e informata delle implicazioni filosofiche di questo concetto fondamentale per Anders e per Arendt, cfr. F. Fischbach, La privation du monde, Vrin, Paris 2011.
[12]H. Arendt, Vita activa, cit., p. 2.
[13]G. Stern, Une interpretation de l’«a posteriori», in “Recherches philosophiques”, 1934, 4, pp.65-80 e Id. Pathologie de la liberté, ivi, 1936, 6, pp. 22-54, trad. it. in G. Anders, Patologia della libertà, intr. di K.P. Liessmann e postfazione di R. Russo, Editrice Palomar,Bari 1993. Si tratta di due saggi che G. Stern (questo il vero nome del filosofo) pubblicò negli anni dell’esilio parigino, rifacendosi al testo di una conferenza che aveva tenuto a Francoforte nel 1929, presso la società kantiana, e di fronte ad un uditorio composto, tra gli altri dalla moglie Arendt, Paul Tillich, Adorno e Horkheimer, dal titolo Die Weltfremdheit des Menschen, andata perduta, il cui testo, però, si può ricostruire dalle traduzioni francesi. Sullo sfondo antropologico di questi saggi andersiani, cfr. P. Faustini, Essere, coscienza e spaesamento tra Wissenssoziologie e antropologia filosofica, in B. Accarino (a cura di), Ratio Imaginis. Uomo e mondo nell’antropologia filosofica, Ponte alle Grazie, Firenze 1991, pp. 149-163, come pure l’introduzione dello stesso Accarino al volume, Tra libertà e decisione: alle origini dell’antropologia filosofica, ivi, pp. 7-63. Più in generale, sul contesto filosofico in cui matura l’antropologia filosofica tedesca del Novecento, sono da vedere i saggi contenuti in A. Gualandi (a cura di), L’uomo, un progetto incompiuto, vol. I: Significato e attualità dell’antropologia filosofica, in “Discipline filosofiche”, XII/1, 2002 e Id. (a cura di), L’uomo, un progetto incompiuto, vol. II: Antropologia filosofica e contemporaneità, in “Discipline filosofiche”, XIII/1 2003.
[14]G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. II, cit., p. 25.
[15]Ivi, p. 14.
[16]Ibid.
[17]Ibid.
[18] Sul rapporto tra Anders e Bloch, cfr. B. Schmidt, Anders versus Bloch, in K. P. Liessmann (hrsg. von), Günther Anders kontrovers, Beck, München 1992, pp. 49-56; A. Münster, Speranza o pessimismo? Ernst Bloch e Günther Anders, in C. Di Marco (a cura di), Un altro mondo è possibile, Mimesis, Milano 2004, pp. 255-270; D. Munnich, Rompre avec le messianisme. Notes sur le rapport de Günther Anders à Ernst Bloch, in “Tumultes”, n. 28-29 octobre 2007, pp. 155-169.
[19]«Io non sono assolutamente stato educato come un ebreo, non ho mai conosciuto un rituale ebraico, e non appartengo neppure all’ebraismo tradizionale, cioè a dire non sono né sionista né israeliano.» G. Anders, Mein Judentum (1974), in Id., Günther Anders Lesebuch, Zürich 1984, tr. it. di E. Mori in “Linea d’ombra”, n. 19, luglio-agosto 1987, pp. 7-14. Su questo testo cfr. Evelyn Adunka, Günther Anders und das jüdische Erbe, in K.P. Liessmann (hrsg. von), Günther Anders kontrovers, cit., pp. 72-80; J. Le Ridet, Günther Anders et l’identité juive, in “Austriaca”, 1992, 35, pp. 87-99.
[20] In questo aspetto, è incolmabile la distanza rispetto alla riflessione di Arendt, la quale, come afferma Portinaro, «attenta più a custodire il «magazzino della memoria» che ad arredare la casa della speranza […] non aveva nella sua opera – in ossequio a un antico pudore filosofico nei confronti delle profezie, ma anche in virtù della sua fede nell’uomo come fattore del cominciamento – ipotecato il futuro».P.P. Portinaro, Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 66.
[21]G. Anders, Mein Judentum, art. cit.
[22]G. Anders, L’uomo è antiquato, cit., p. 243.
[23] Id., Über die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit è il titolo del V capitolo del primo volume di Antiquiertheit des Menschen,, successivamente raccolto, insieme ad altri saggi sullo stesso argomento, in G. Anders, Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen zum atomaren Zeitalter, Beck, München 1981.
[24] J. Taubes, Abendländische Eschatologie, Matthes und Seitz, München 1991, p. 4. Cfr. N. Hofmann, Nicht mehr. Noch nicht. Günther Anders und Jacob Taubes, in R. Faber – E. Goodman-Thau – Th. Macho (Hrsg.), Abendländische Eschatologie. A Jacob Taubes, Konigshausen & Neumann, Würzburg 2001, pp. 375-384.
[25]È interessante un’annotazione di Jacob Taubes su Günther Anders a proposito della persistenza del pensiero apocalittico nella cultura contemporanea, a conclusione di una lunga riflessione storico-filosofica di una giornata del gruppo di ricerca “Poetik und Ermeneutik” nel 1970: «Del cristianesimo apocalittico Franz Overbeck poteva a ragione dire che aveva iniziato a rifiutare una storia per sé e a subirne una proprio contro le proprie intenzioni. Non viene frenato il corso della storia attraverso l’attesa apocalittica del Cristianesimo, ma si è attenuata l’attesa apocalittica di una fine di tutta la storia attraverso il procedere della storia. In una forma storico-profana i termini apocalittici assumono però oggi un senso completamente non metaforico: su questo Günther Anders, un amico di Benjamin, che gli interpreti francofortesi di Benjamin da lungo tempo hanno dimenticato [lasciato a sinistra], ha da dire cose decisive. Il concetto di progresso, che fu il grimaldello per la filosofia della storia al tempo dell’illuminismo e dell’idealismo tedesco, è fuori uso. Una critica del concetto di progresso è stata intrapresa da R. Koselleck in direzione di una nuova storiografia, in cui gli ultimi resti di una esperienza apocalittica siano espulsi dalla nostra coscienza storica. Una tale critica però potrebbe però essere indirizzata in direzione opposta e legarsi agli ultimi resti di un’esperienza apocalittica della filosofia della storia senza fare ricorso a schemi di storia sacra, per porla al servizio di un’analisi profana dell’attualità.» R. Koselleck – W.-D. Stempel (Hrsg.) Geschichte. Ereignis una Erzählung (Poetik und Ermeneutik 5), W. Fink, München 1973, pp. 498 sgg., cit. da N. Hofmann, art. cit., p. 383.
[26]Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di Clara Gallini, Einaudi, Torino 1977 (2002). Cfr. anche B. Baldacconi – P. Di Luccino, Dell’apocalisse. Antropologia e psicopatologia in Ernesto de Martino, Guida, Napoli 2005.
[27]Ivi, p. 468. Anders è citato poche pagine dopo (pp. 476 sgg.) come interprete della nuova situazione atomica, contrassegnata dal predominio del «gesto tecnico», che, per gli effetti spropositati che è in grado di produrre, rende vane le categorie morali di colpa e punizione da sempre associate agli atti di violenza e di sopraffazione.
[28]Werner Reimann, Die Verweigerte Versöhnung, Passagen Verlag, Wien 1990. Anders parla del carattere “religioso” dell’epoca contemporanea, in quanto appartengono ormai all’umanità attributi che erano stati pensati, in passato, come propri della divinità, in particolare l’onnipotenza distruttiva (reductio ad nihil). Con la metafora dell’apprendistastregone, Anders si riferisce al potere immenso che, originato dalla capacità tecnico-scientifica degli uomini, è sfuggita al suo controllo, sovrastandolo e arrivando a minacciarne la sopravvivenza: «ciò che qui viene ammesso come religiosum non è nulla di positivo, bensì solo la terribilità che trascende ogni dimensione umana del fare umano». G. Anders, L’uomo è antiquato, II, cit., p. 379.
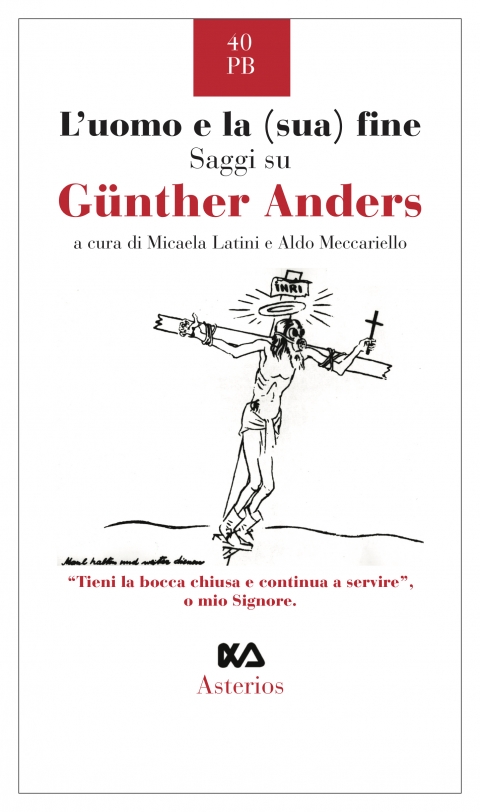 https://www.asterios.it/catalogo/luomo-e-la-sua-fine-saggi-su-g%C3%BCnther-anders
https://www.asterios.it/catalogo/luomo-e-la-sua-fine-saggi-su-g%C3%BCnther-anders
