Geometrie dell’imperialismo nel XXI secolo (1/2)

È un grande onore per me tenere l’annuale Edward Said Memorial Lecture[1] questa sera all’Università americana del Cairo. È anche un onore pericoloso, non solo per la qualità di coloro che mi hanno preceduto, ma anche per le circostanze drammatiche in cui ci troviamo. Tornerò su questo punto.
Il titolo che vi ho dato viene da un saggio di Giovanni Arrighi, La geometria dell’imperialismo, pubblicato per la prima volta nel 1978 (lo stesso anno de L’Orientalisme), oggi meno noto di altre sue opere e di taglio curiosamente “strutturalista”[2]. Credo che sia un contributo molto interessante all’analisi delle variazioni dell’ imperialismo, soprattutto se proviene da uno dei maggiori esponenti della discussione post-marxista sulla configurazione globale del capitalismo e delle sue successive egemonie storiche.
Non voglio ripetere le sue parole, ma voglio provare ad articolare alcune riflessioni sulla complessità del fenomeno “imperialista”, sulla sua centralità in qualsiasi interpretazione della storia moderna e sulle sue trasformazioni nell’ultimo periodo. È in questo contesto che collocherò l’importanza del contributo di Edward Said, che si potrebbe erroneamente pensare riguardi solo una sorta di conseguenza della struttura stessa. Naturalmente, dovrò eludere o semplificare molti degli importanti dibattiti sui concetti e sulla loro applicazione, ma questo è il rischio che corro per attirare l’attenzione su quella che, oggi, mi sembra la questione più urgente.
Certo, questa è una presentazione teorica. Ma — come spero vedrete — non può essere dissociata da un impegno militante nelle lotte antimperialiste, in tutta la loro diversità e unità problematica. Sono la nostra unica speranza di diventare, o tornare a essere, attori di un processo di emancipazione collettiva dalla violenza e dallo sfruttamento. Alla fine di questo articolo, cercherò, molto brevemente e molto astrattamente, di tracciare alcune linee guida per pensare a queste lotte, sulla base di una rappresentazione aggiornata della struttura di dominio a cui il nostro mondo è stato sottoposto per più di cinque secoli e che oggi sembra condurlo verso una catastrofe planetaria.
Per quanto astratte possano essere (e mi dispiace di non poter fare di meglio in questo contesto), le mie proposte non possono sfuggire alla pressione delle circostanze in cui ci incontriamo. Sono semplicemente tragiche. Parlando con l’invocazione di Edward Saïd, come potrei non essere ossessionato dalle immagini di pulizia etnica e di sterminio che ci giungono ogni giorno dalla Palestina (e ora anche dal Libano)? E come non essere ossessionato dalla domanda sul perché il “mondo” (noto anche come “comunità internazionale”) non voglia o non possa porre fine a questa barbarie?
Ma naturalmente ho altri pensieri, altri ricordi in testa su questa regione di cui l’Egitto è il centro… Intraprendendo il mio “Viaggio in Oriente”, penso a ciò che di veramente unico c’è in questa regione, sia per il suo contributo alla civiltà sia per la violenza delle esperienze che ha subito. Una regione in cui, fin dagli albori di quella che chiamiamo “storia”, gli imperi hanno combattuto per l’egemonia (una delle mie tesi sarà che l’imperialismo moderno, con tutte le sue caratteristiche specifiche, continua questa lunga storia).
Una regione che, per tutto l’Ottocento e il Novecento, è stata costantemente in gioco nelle rivalità imperialiste, ma anche teatro di eroiche rivolte che hanno cercato di invertire il corso della storia e di immaginare il futuro all’insegna della libertà, finendo però troppo spesso per essere schiacciate dalla repressione e dalla superiorità delle forze conservatrici interne ed esterne. Potete quindi immaginare cosa significhi per me parlare oggi proprio vicino a Piazza Tahrir! E non posso dimenticare la cosa più tragica di tutte: i tre genocidi che vi hanno avuto luogo negli ultimi anni, in Darfur, Siria e Gaza. Non si può dire che discutere di imperialismo qui sia solo una questione di scienza storica!
Veniamo ora al primo punto. Mi concentrerò sul rapporto tra imperialismo e guerra, ed ecco perché. Dopo i saggi che, all’inizio del XX secolo, hanno inaugurato la problematica dell’imperialismo in una prospettiva socialista e marxista: Hobson, Hilferding, Rosa Luxemburg, Kautsky, Lenin, Trotsky e altri, non c’è mai stato un punto di arresto. Il problema non ha mai smesso di evolversi.
Ma ci sono stati periodici “ritorni” a punti significativi di eresia, come quando David Harvey, nella sua analisi del “nuovo imperialismo” basato sull’“accumulazione per espropriazione” (a cui attingerò in parte), ha ripreso le idee di Rosa Luxemburg in L’accumulazione del capitale (1913) sull’espropriazione violenta dei contadini nelle “periferie” coloniali del capitale industriale[3]. Soprattutto, esiste una tensione permanente tra le teorie che pongono in primo piano il fenomeno politico dell’imperialismo (in altre parole, l’azione dello Stato con i suoi “marchi di sovranità”, per dirla con Bodin e Hobbes[4]) e le teorie (principalmente marxiste) che lo considerano come lo sviluppo di uno “stadio” o “modo” dello sviluppo capitalistico, con i suoi antagonismi caratteristici.
Eppure, fin dall’inizio, questa tensione mi sembra dettata dalla necessità di rendere conto di un fenomeno che è l’emergere della guerra al centro stesso dell’economia di una società il cui principio di organizzazione e di progresso (“commercio”, nel senso più ampio del termine) dovrebbe promuovere la pace. Fu (per usare l’espressione di Lenin) la “catastrofe imminente” della guerra mondiale del 1914 a cristallizzare i dibattiti sul rapporto tra capitalismo e nazionalismo, colonizzazione, militarismo e guerra[5]. E fu la convinzione che questa combinazione spingesse la società “borghese” a un limite assoluto e insostenibile che portò i teorici più radicali dell’epoca a porre l’alternativa: imperialismo o rivoluzione, sostenuta dalla duplice convinzione che l’imperialismo crea problemi che è impossibile risolvere e che la rivoluzione, appunto, fornisce la soluzione (o almeno ne sblocca la possibilità). Tornerò su questo punto, naturalmente.
Ma per il momento voglio difendere l’idea che, per una teoria dell’imperialismo, la guerra non può essere vista come una conseguenza particolare del fenomeno in esame. È la guerra a costituire il problema fondamentale, la questione primaria che dà origine al concetto. È quindi alla guerra che dobbiamo tornare per valutare cosa è cambiato o persistito, e in che proporzione, nella struttura dell’imperialismo e nelle configurazioni delle sue “tendenze”. Non c’è nulla di contingente nell’articolazione di imperialismo e guerra. Ma non può nemmeno essere dedotta da una semplice definizione.
Quando ci interroghiamo su questo rapporto, non parliamo solo di “guerre imperialiste” o “guerre dell’epoca imperialista”, ma del legame intrinseco tra imperialismo e guerra. È su questo punto che avanzerò due ipotesi.
La prima è la seguente: nella sua accezione oggi dominante (marxista o post-marxista), che non lo separa dal capitalismo come modo di produzione basato sull’accumulazione di valore monetario, non c’è dubbio che l’imperialismo abbia coinciso con una nuova modalità di conquista imperiale, simbolicamente segnata dall’apertura dell’America nel 1492 alla colonizzazione europea, che si sarebbe poi estesa al mondo intero. Questo, tuttavia, non segnò un’interruzione nella storia degli imperi e delle loro rivalità. Al contrario, segnò l’inizio di un periodo in cui l’impero come forma politica acquisì una vitalità senza precedenti.
L’imperialismo non rappresenta una rottura con la successione degli imperi, ma segna piuttosto un nuovo momento in una storia molto lunga. Questo potrebbe semplicemente significare che l’imperialismo moderno implica ancora la conquista e il dominio, ed è persino guidato dal sogno imperiale di un potere universale, che era chiaramente il caso, non solo per l’Impero britannico, ma anche per gli imperi “repubblicani” francese e americano.
Ma possiamo fare un passo in più, perché l’impero come forma politica ha un legame istituzionale con la guerra e con la funzione politica che essa svolge. Lo esprimerò forgiando un assioma “romano” che vale ancora oggi: gli imperi fanno sempre la guerra alle loro “frontiere” (che spostano continuamente) per creare lo spazio per il commercio, la legislazione e la cultura, in altre parole la “pace”, ma è vero anche il contrario: fanno la pace e sviluppano le sue istituzioni per poter preparare e fare la guerra.
La seconda proposizione non è meno vera della prima, anzi ne costituisce la verità da un punto di vista materialista. La guerra è insita nell’imperialismo come lo era negli imperi. Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant : vale sempre la pena rileggere Tacito[6].
Per quanto riguarda la mia seconda e più importante ipotesi, cercherò di sostenerla con formulazioni prese in prestito da due autori — Lenin e Carl Schmitt — politicamente inconciliabili, ma accomunati da una visione realistica dei conflitti di potere nel XX secolo. Al centro del saggio di Lenin L’imperialismo, fase suprema del capitalismo[7] c’è l’idea della “divisione del mondo” tra le potenze coloniali, una divisione caratterizzata dalla sua intrinseca instabilità, che lungi dal portare a una distribuzione permanente o “equilibrata” delle sue parti tra sovranità equivalenti, comporta al contrario una violenta lotta per la sua ridivisione.
Se c’è un’idea di Lenin che la storia ha confermato vividamente, è ovviamente questa, come dimostra una storia di conflitti incessanti che va dalla Conferenza di Berlino (1885) in cui l’Africa esplorata e inesplorata (il “continente nero”) fu spartita tra le potenze coloniali europee, all’emergere di potenze imperialiste extraeuropee in America e in Asia e alla “guerra fredda” (la “divisione di Yalta”), passando per le due guerre mondiali (e quindi il patto tedesco-sovietico), per culminare infine dopo il 1989 nella costruzione di un unico “ordine liberale” militarizzato.
Una delle domande decisive per la nostra indagine è quindi se e come tale idea sia applicabile alla nostra situazione attuale e alle sue tendenze evolutive, in particolare per chiarire il significato della parola d’ordine “multilateralismo”. È chiaro, tuttavia, che questa discussione presuppone un notevole ampliamento della caratterizzazione leninista, che si basa sulla funzione decisiva dei territori e dei confini territoriali, così come possono essere identificati su una mappa del mondo. Gli imperi di cui ci stiamo occupando basano il loro potere sull’investimento e sulla redditività del capitale.
I territori che contano per loro non sono entità puramente spaziali; sono spazi aperti con la forza all’appropriazione di risorse monopolizzabili: risorse energetiche (carbone, petrolio, uranio, ecc.), risorse minerarie e agricole (il cui sfruttamento sconvolgerà l’ambiente), risorse umane (popolazioni suscettibili di essere schiavizzate, trasferite, messe al lavoro, arruolate nell’esercito, ecc.) Ma ben presto ci si rese conto che gran parte di queste risorse potevano essere controllate ed estratte senza ricorrere al dominio diretto (o alla “sovranità” sul territorio), a patto ovviamente che fossero disponibili i mezzi (monetari e militari) per fornire un irresistibile eccesso di potere.
Questo, come sappiamo, è stato il segreto dell’imperialismo americano, che ha dato alla “divisione del mondo” un carattere più astratto, oscurato sulle carte geografiche se non sul terreno, controllando i territori non come colonie (con poche eccezioni) ma come mercati, in modo da costruire un impero globale la cui estensione era limitata solo dalla capacità degli Stati Uniti di reprimere le insurrezioni e di investire capitali ovunque nel mondo.
A sua volta, però, questo modello è stato “superato” da un modello completamente diverso di condivisione del mondo (e di lotta per la sua ri-condivisione), che non riguarda gli spazi terrestri ma gli spazi “virtuali” (o immateriali) (l’insieme dei quali costituisce il metaverso), distribuiti (e ridistribuiti, o contesi) tra gli imperi della comunicazione[8]. Tale condivisione crea i propri “territori” appropriandosene, e i suoi “padroni” non sono tanto gli Stati quanto le imprese multinazionali con le loro “reti” per la distribuzione e la raccolta dei dati, che controllano l’attività degli Stati piuttosto che essere controllate da essi.
Questa forma rivoluzionaria di “territorialità” acquisirà un’autonomia sufficiente a relegare sullo sfondo la lotta per l’egemonia che oggi sembra essere in procinto di strutturare “geopoliticamente” l’ordine mondiale (tra gli imperi industriali, che sviluppano modelli diversi di “capitalismo”, rivali e complementari tra loro, ossia Cina e Stati Uniti)? E che tipo di conflitti ne deriveranno? Queste sono chiaramente le domande che incombono sul nostro futuro immediato.
A questo punto, è opportuno fare una digressione sull’opera di Carl Schmitt. È innegabile la convergenza tra la “divisione del mondo” leninista e la sua idea di Landnahme (“presa” della terra) sviluppata nel libro del 1950: Il Nomos della terra e il diritto internazionale dello Jus Publicum Europaeum, dove la storia della costituzione degli Stati nazionali europei (dopo la fine delle guerre di religione nel XVII secolo, che hanno portato all’“ordine di Westfalia”) è correlata al fatto che queste stesse nazioni sono in uno stato di guerra permanente per espandere i loro imperi e spogliarsi a vicenda delle loro colonie[9].
Ovviamente, Lenin e Schmitt non “concludono” la loro diagnosi della crisi del nomos allo stesso modo: Per Lenin, la rivoluzione è la conseguenza immediata e ineluttabile della crisi dell’imperialismo, mentre per Schmitt (dichiaratamente controrivoluzionario), ciò che ne risulterà è una nuova geometria dell’imperialismo, caratterizzata dalla costituzione di Grossräume (“grandi spazi geopolitici”) che sono una nuova varietà di imperi regionali (la cui risonanza con alcune questioni contemporanee: “multipolarità” e ‘scontro di civiltà’)[10].
Ma ciò che trovo più illuminante nelle sue analisi è l’idea che la divisione del mondo non sia solo una (ri)distribuzione di terre, risorse e popolazioni, ma anche una distribuzione delle forme di guerra (e più in generale delle modalità della violenza) tra le regioni del pianeta[11]. Questa distribuzione opera contemporaneamente a due livelli: è una distribuzione tra Stati imperialisti, ed è una distribuzione tra la regione in cui vivono i “padroni” (o i “popoli-padroni”) e la regione in cui vivono i “sudditi” (o i futuri sudditi, già segnati per la conquista) — quelli che in seguito saranno chiamati “centro” e “periferia”.
La violenza esercitata al centro, dove è in gioco il potere sovrano (Herrschaft), e quella esercitata in periferia, per stabilire e rassicurare in modo permanente il dominio dei padroni sui barbari che dovevano sottomettere, educare e far lavorare, sono qualitativamente e quantitativamente diverse: la seconda deve essere permanente, atroce ed essa stessa barbara, mentre la prima è intermittente (separata da trattati di pace) e pretende di rimanere civile (in virtù delle “leggi di guerra”). Si “trattiene” (Hegung des Krieges) mentre la seconda si scatena.
La stabilità e persino la plausibilità di questa distribuzione sono tutt’altro che certe (lo testimoniano le atrocità commesse durante la Seconda guerra mondiale o attualmente in Ucraina), ma vedo la possibilità di utilizzarla al contrario : In un’ottica post-schmittiana (che è anche anti-schmittiana), riterrei che l’ineguale distribuzione di forme eterogenee di violenza sia in quanto tale uno dei meccanismi che tracciano i confini che separano “due mondi” all’interno dello stesso “mondo” (e quindi due “umanità” o due “razze” all’interno della stessa “specie umana”). Ed è proprio questa la forma dell’imperialismo come forma sociale e antropologica nell’era moderna. In diverse occasioni è stato distorto e spostato (e senza dubbio continuerà ad esserlo, a costo di terribili sofferenze e devastazioni ambientali), ma il suo principio è stato mantenuto. Lo stiamo vedendo proprio ora a Gaza.
Concludiamo su questo punto e torniamo alle angoscianti questioni del presente. In un mondo che è più che mai diviso in Stati, nazioni e regimi in competizione tra loro, ma che sembra anche aver raggiunto un grado di interdipendenza senza precedenti tra le sue “parti” costitutive, e che si trova chiamato da eventi diversi come una pandemia, una crisi valutaria globale, ma soprattutto dalla catastrofe ambientale a prendere coscienza di alcuni interessi vitali comuni a tutta l’umanità, e quindi a far prevalere la sua unità sulle sue divisioni, come possiamo ancora riconoscere i segni dell’impero? E come definire il regime globalizzato di guerre condotte — per terra e per aria, e persino nello spazio “virtuale” dell’infosfera — in nome di valori incompatibili all’interno di questo mondo “unificato”?
Alla prima domanda risponderei ipoteticamente: sono gli imperi in declino ad essere i più violenti (o i più crudeli nel modo in cui fanno la guerra), perché si sentono messi all’angolo sia dall’erosione dei loro privilegi sia dalla rovina della loro pretesa di “grandezza” (o di elezione)[13]. La Russia e gli Stati Uniti d’America illustrano oggi questa tesi, anche se a livelli diversi di imperialismo[14]: per la prima, è necessario “ricostituire l’unità del Mir russo che l’URSS aveva preservato e che il suo crollo ha dissolto; per i secondi, è necessario ’rendere di nuovo grande l’America”…
La mia risposta alla seconda domanda è che abbiamo raggiunto una fase di sterminio generalizzato. Prendo in prestito questo termine dal famoso saggio dello storico Edward P. Thompson (uno dei leader del movimento Est-Ovest per il disarmo nucleare): Notes on Exterminism, the Last Stage of Civilization (1980)[15], il cui titolo parodiava intenzionalmente Lenin. Scritto all’apice della “corsa agli armamenti” della Guerra Fredda, insisteva sull’idea che il rischio di annientamento del pianeta derivasse non solo dalle politiche e dalle ideologie imperiali delle due “superpotenze”, ma anche dalle dimensioni delle industrie degli armamenti e dal loro posto centrale nell’economia.
Questo è ancora vero, ma credo che si possa fare un ulteriore passo avanti nel concetto di sterminio per descrivere la normalizzazione dello stato di eccezione che è la guerra nel mondo di oggi: Non includo solo le guerre ufficialmente definite come “guerre tra Stati” (come quella in Ucraina — tra l’altro più da parte ucraina che russa), ma anche le “guerre civili” e persino le “guerre private” (se pensiamo alla porosa separazione tra guerra e crimine in alcune parti del mondo), il “terrorismo” e il “controterrorismo” condotti dagli Stati contro i loro nemici interni o esterni.
Naturalmente, tutte queste forme hanno storie e cause particolari, ma nel loro insieme (con la produzione e la diffusione delle armi sullo sfondo), formano una distribuzione globalizzata della violenza armata che comprende tutti i gradi di violenza e non risparmia nessuna società o regione del mondo, un continuum tra due estremi: Da un lato, il genocidio perpetrato contro intere popolazioni da masse razziste “non organizzate” o (soprattutto) da Stati ed eserciti altamente organizzati (come Israele); dall’altro, lo sterminio potenziale nel contesto di una guerra nucleare dichiarata o come risultato di una “escalation” incontrollata.
Lo sterminazionismo non è quindi l’ultimo, ma il più recente e “basso” stadio dell’imperialismo, la cui violenza multilaterale fa sì che non si possa davvero immaginare l’avvento di un altro mondo. Non c’è nulla di felice in questo…
Probabilmente mi sono dilungato molto su questo primo punto, perché mi sembrava particolarmente attuale. Passerò ora al secondo, che riguarda l’idea di imperialismo come “fase” o “periodo” della storia del capitalismo, e di conseguenza la questione di quale sia la forma di capitalismo in cui viviamo oggi.
L’aggettivo russo del titolo di Lenin (vyschaia) viene comunemente tradotto come “supremo” o “superiore”, ma a volte viene inteso come uno stadio “ultimo” o “ultimo” (nel senso di più recente). Ciò dimostra che l’idea di Lenin contiene un’ambiguità, immediatamente legata alla convinzione che l’imperialismo (“epoca di guerre e rivoluzioni”) corrisponda alla catastrofe finale nello sviluppo del capitalismo come formazione socio-economica: si apre un momento messianico in cui l’umanità si trova di fronte all’alternativa dell’autodistruzione o della ricostruzione su basi radicalmente diverse (parola di Rosa Luxemburg: “socialismo o barbarie”[16]).
Certo, è diventato molto difficile mantenere questa visione escatologica del senso della storia — anche e soprattutto se deve costituire l’“orizzonte di attesa” (Erwartungshorizont) in cui pensano i rivoluzionari, per i quali vedere il capitalismo come forma insuperabile dell’esistenza umana è un’idea insopportabile. Ciò non significa, tuttavia, che l’idea di associare una riflessione sull’imperialismo all’analisi delle fasi o formazioni successive della storia del capitalismo sia priva di validità. Ma da questo punto di vista, vorrei dire molto rapidamente che si sono verificate due rettifiche rispetto alla problematica leninista, di cui dobbiamo tenere conto. Esse guardano in direzioni temporali opposte.
La prima è quella proposta dai teorici del “sistema-mondo capitalista”[17]: Essi rettificano l’idea che i tratti essenziali (o le tendenze storiche) del capitalismo possano essere interamente colti dall’analisi delle forme “avanzate” che esso assume nel “centro” dell’economia mondiale[18], perché ciò che è decisivo per la sua evoluzione è il rapporto didipendenza tra il centro e la periferia (in cui prevalgono modi di produzione diversi dal lavoro salariato, non meno “capitalistici”, ma basati su altre modalità di sfruttamento della forza lavoro). Questa dipendenza è reciproca, ma non simmetrica. È sempre esistita, in quanto correlata al capitalismo. Ciò significa che l’imperialismo del capitale è originale, non è una fase tardiva (e tanto meno “ultima”) della storia del capitalismo. Non è mai esistita una forma di capitalismo che non fosse imperialista, anche se le sue forme sono costantemente cambiate. L’imperialismo non è quindi una nozione escatologica, ma un concetto variazionale (o differenziale).
Da qui l’importanza dell’altra rettifica, che guarda in direzione opposta, i cui autori affermano più o meno esplicitamente di essere gramsciani[19]. Si tratta dell’idea che nuove fasi o epoche della storia del capitalismo, caratterizzate da una nuova configurazione delle classi e delle lotte di classe, siano separate da momenti di incertezza storica (più che di “transizione”) in cui le contraddizioni non si risolvono senza rivoluzioni che investano l’intero quadro istituzionale della società[20]. Questa idea, che potrebbe sembrare banale, diventa problematica, ma anche, mi sembra, illuminante, se accettiamo che la rivoluzione può muoversi in direzioni opposte.
Gramsci stesso ha tratteggiato questa idea (difficile per un comunista! ) attraverso la paradossale categoria di “rivoluzione passiva” (mutuata da uno storico italiano del primo Ottocento), che egli utilizzò in particolare per descrivere le trasformazioni industriali, sociali e culturali del “fordismo” americano, e che possiamo facilmente estendere ai compromessi di classe che, in America sotto il nome di “New Deal” e in Europa sotto quello di “socialdemocrazia”, hanno riformato il capitalismo con il sostegno di una frazione significativa della classe operaia organizzata[21].
Le politiche neoliberiste che hanno iniziato a prendere forma negli ultimi anni della Guerra Fredda e sono diventate dominanti su scala globale dopo il crollo dei regimi comunisti (tranne che in Cina, un punto decisivo), ci permettono di fare un ulteriore passo verso questa idea: questa trasformazione del sistema capitalistico imperialista alla fine del XX secolo, che oggi comanda tutte le nostre vite, è stata effettivamente una controrivoluzione. Ma dobbiamo ammettere che anche le controrivoluzioni sono rivoluzioni, con l’importante differenza che mirano a ripristinare una struttura gerarchica nella società, piuttosto che a “capovolgerla”[22].
Introdurrò ora la categoria che da tempo io (e altri) utilizzo per definire il capitalismo in cui viviamo oggi: capitalismo assoluto[23]. So che può essere ambiguo, ma credo che valga la pena di correre il rischio per mettere in luce le questioni in gioco. Uso l’aggettivo “assoluto” sia per analogia con “monarchia assoluta” (per designare una forma di capitalismo che regna incontrastata, o almeno ha ridotto sulla difensiva i suoi antagonisti classici), sia in modo dialettico (quasi hegeliano), in contrapposizione a quello che Immanuel Wallerstein ha chiamato “capitalismo storico”: quello che corrispondeva alle successive forme di polarizzazione del mondo tra “centro” e “periferia”. Il capitalismo assoluto “allevia” il capitalismo storico. Perché, vi chiederete, non ci accontentiamo della categoria di neoliberismo?
 https://www.asterios.it/catalogo/capitalismo-storico-e-civilt%C3%A0-capitalistica
https://www.asterios.it/catalogo/capitalismo-storico-e-civilt%C3%A0-capitalistica
Perché, a mio avviso, corrisponde solo a una parte dei tratti che caratterizzano il nuovo capitalismo, e suggerisce che per interpretarli dobbiamo innanzitutto risalire all’immemorabile conflitto tra politiche economiche che danno il primato o alle regolamentazioni statali e alle imprese, o alle operazioni di “libera concorrenza” e alle forze di mercato[24]. Ciò che rimane in ombra è il modo in cui le precedenti forme di antagonismo di classe e di conflitto sociale sono state “superate” o eliminate. Al contrario, credo che dobbiamo analizzare il capitalismo assoluto come intrinsecamente post-socialista e post-coloniale.
È post-socialista perché riesce a utilizzare le istituzioni e i poteri statali che erano stati rafforzati durante il “momento socialista” dell’economia mondiale (1917-1968) e allo stesso tempo si impegna a smantellare o dissolvere il sistema di diritti sociali incorporato dagli Stati nel XX secolo (in modo diverso a seconda del regime) nella loro costituzione materiale della “cittadinanza”. Particolarmente importante è lo studio delle trasformazioni “post-socialiste” nella Cina comunista, che viene sempre più considerata come lo Stato guida negli sviluppi globali. La Cina è tipica ed eccezionale per il modo in cui è “andata oltre” il socialismo verso un nuovo capitalismo. Dopo essere stata più intensamente socialista, sta assumendo la guida nella costruzione del nuovo capitalismo[25].
Ma il capitalismo assoluto è anche postcoloniale, perché la tendenza alla mercificazione totale dell’esistenza e alla delocalizzazione dei processi produttivi (la formazione di “catene del valore” globali) che lo caratterizza si è potuta completare solo grazie all’abbattimento delle barriere degli imperi e all’apertura delle economie periferiche ai flussi di merci e capitali (e anche di persone) che la decolonizzazione formale (quella dell’“indipendenza”) ha comportato[26].
Per chiarire le cose, richiamiamo l’attenzione su alcune caratteristiche sorprendenti, sia quantitative che qualitative. Nell’attuale economia globalizzata, la polarizzazione delle condizioni sociali si è forse ridistribuita, ma non si è affatto attenuata: al contrario, ha raggiunto livelli senza precedenti, con la diffusione della povertà e dell’insicurezza di massa da un lato e la concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani di una piccola minoranza di finanzieri e rentiers dall’altro. Ma la sua distribuzione geografica e nazionale sta cambiando molto rapidamente. I confini che dividevano il mondo del “capitalismo storico” sono stati ridisegnati e moltiplicati. Non c’è dubbio che la povertà estrema sia ancora concentrata nel “Sud” (in particolare in Africa e nel Sud-Est asiatico[27]), ma è anche nel “Sud” che stanno emergendo i campioni più aggressivi del nuovo capitalismo finanziario e industriale.
Da qui la problematicità dell’idea di una strategia “antimperialista” che riunisca i Paesi e le masse del “Sud globale”, rappresentandone gli interessi comuni. Ma, al contrario, i processi di precarizzazione e riproletarizzazione stanno aumentando nel “Nord”, dove i lavoratori sono sempre meno protetti dalle istituzioni dello “Stato sociale”[28] e beneficiano sempre meno dei privilegi dell’impero. Questo, come sappiamo, provoca violente reazioni sociali, dette “populiste” e niente meno che progressiste. Quindi c’è un “Nord” nel “Sud” e un “Sud” nel “Nord”, che io interpreto dicendo che la divisione dell’umanità in condizioni di disuguaglianza, caratteristica del capitalismo e strettamente legata alla struttura dell’imperialismo, è ancora presente, ma che la sua topografia — o se volete la sua “geometria” — ha subito una rivoluzione. Non si tratta solo di una ridistribuzione delle grandezze economiche e demografiche, ma di una nuova divisione del mondo. Tornerò su questo punto.
Concludo con un altro aspetto di questa geometria, che ci porta a definire la principale contraddizione (come si diceva nel vecchio codice marxista) di questo “nuovo imperialismo” (David Harvey). Significativamente, egli ci riporta dal presente agli inizi della storia dell’imperialismo. Il capitalismo assoluto, dominato dalle politiche monetarie neoliberiste e dalle strategie di profitto a breve termine sui mercati finanziari, conferisce una funzione centrale alla gestione e allo sfruttamento del debito, facendone il principale strumento di dominio su individui, imprese e Stati[29].
 https://www.asterios.it/catalogo/la-grande-rapina
https://www.asterios.it/catalogo/la-grande-rapina
Ma i Paesi e le società che si trovano ai due estremi del rapporto di interdipendenza finanziaria reagiscono ovviamente in modo opposto: un debito enorme (pubblico e privato) non ha lo stesso significato per un’economia dominata come quella argentina, costantemente minacciata di bancarotta e soggetta a piani di risanamento e riforme strutturali imposte dal FMI, come per gli Stati Uniti, che contraggono prestiti nella loro stessa moneta — quella che sono riusciti a far diventare la valuta di riserva mondiale — e godono quindi di facilitazioni creditizie praticamente illimitate. Quanto agli altri Paesi (compresi quelli dell’Unione Europea), in varia misura navigano tra i due poli, alle prese con la “sostenibilità” del loro debito[30]. Ma qual è la soluzione offerta dall’imperialismo contemporaneo ai Paesi fortemente indebitati per consentire loro di sopravvivere e continuare a contribuire al processo di “accumulazione su scala globale” (Samir Amin)?
Non c’è una risposta semplice (e potete immaginare che non ho pretese di competenza in questo campo), ma trovo difficile ignorare o minimizzare il seguente aspetto: questi Paesi sono sottoposti a una costante pressione per tornare a quella che è sempre stata la “specialità” della periferia fin dai tempi della rivoluzione industriale e dello sviluppo delle tecnologie del “carbonio”, ovvero l’economia estrattiva nelle miniere, l’agricoltura estensiva e la pesca industriale, lo sfruttamento eccessivo delle foreste e l’esportazione di materie prime nella parte bassa della catena del valore. Questa economia non si basa sulla schumpeteriana “distruzione creativa” (innovazione tecnologica che elimina i processi esistenti e massimizza quello che Marx chiamava “plusvalore relativo”), ma su una produzione che distrugge le proprie risorse e i propri mezzi[31].
Questo mi porta a pensare che la contraddizione fondamentale dell’imperialismo contemporaneo, nella misura in cui coincide con lo sviluppo del capitalismo assoluto, non sia identificabile né come una “pura” contraddizione sociale (come illustrato dalla crescita delle disuguaglianze globali), né come una “pura” contraddizione ecologica (di cui l’estrattivismo è un fattore essenziale sia per il suo contributo diretto al cambiamento climatico sia per il suo legame con le nuove tecnologie ultra-inquinanti ed energivore), ma come una combinazione antagonista delle due[32].
In un passaggio impressionante del Manifesto comunista, Marx ed Engels spiegano che il capitalismo ha raggiunto il suo limite assoluto come modo di produzione quando, dopo aver spinto i lavoratori il cui sfruttamento lo sostiene al di sotto del livello di sussistenza, inizia a distruggere la condizione principale della sua stessa riproduzione, cioè il lavoro vivo. Ma una soluzione viene subito in mente: “l’esproprio degli espropriatori”, ovvero la riappropriazione da parte dei lavoratori dei loro mezzi di produzione e di esistenza.
È molto allettante vedere nelle tendenze del capitalismo assoluto di oggi una forma ancora più radicale di autodistruzione, poiché non sono solo le vite umane a essere continuamente annientate, ma anche le condizioni biologiche ed ecologiche senza le quali non può esserci semplicemente più vita (umana o di altro tipo). Con il trionfo del capitalismo assoluto, il terreno stesso su cui operava — sotto forma di territorio, ambiente o impero — sta scomparendo. È vero che sempre più persone si rendono conto della gravità di questa minaccia e dell’urgenza di affrontarla con tutti i mezzi possibili, ma il collegamento di questa consapevolezza con movimenti politici che affrontino la disuguaglianza del mondo è praticamente impensabile, almeno finché gli Stati e le società stesse continueranno a essere governati dalla regola del massimo profitto e non della conservazione della vita.
Finché, inoltre, non prenderà forma un programma credibile che combini l’obiettivo della decrescita razionale con quello dell’eliminazione della povertà. Un tale programma potrebbe essere chiamato socialismo post-imperialista. Ma non sembrano esistere (ancora) né il suo linguaggio né le forze che lo imporrebbero. Come potete vedere, questa seconda parte della mia presentazione non si conclude in modo più ottimistico della prima.
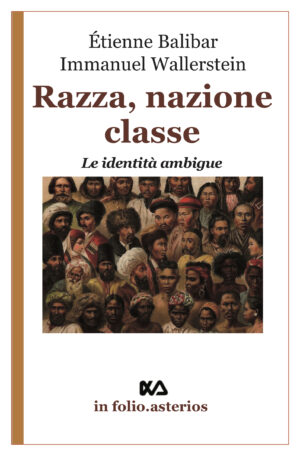 https://www.asterios.it/catalogo/razza-nazione-classe
https://www.asterios.it/catalogo/razza-nazione-classe
Note
[1] Questo testo è l’adattamento francese della Edward Saïd Memorial Lecture 2024, tenuta all’Università americana del Cairo, il 2 novembre 2024, su invito del Dipartimento di inglese e letteratura comparata.
[2] Giovanni Arrighi, La geometria dell’imperialismo. I limiti del paradigma di Hobson (1978), edizione rivista, con una nuova postfazione, Verso Editions 1983.
[3] David Harvey, Il nuovo imperialismo , Oxford University Press 2005.
[4] Cfr. Étienne Balibar, “Prolegomeni alla sovranità”, in Noi cittadini d’Europa? I confini, lo Stato, il popolo , Éditions La Découverte, Parigi 2001.
[5] Il testo più noto è “La catastrofe imminente e i mezzi per evitarla” del settembre 1917 (immediatamente prima della Rivoluzione d’Ottobre), che riprende e accentua i temi sviluppati da Lenin a partire dal 1915 (in Œuvres , Parigi – Mosca, 1959, volume 24.
[6] Tacito, Vita di Agricola , 30.
[7] sottotitolato “Essai de vulgarisation”, scritto nel 1916 e pubblicato l’anno successivo, nell’aprile 1917 tra le due “rivoluzioni”. Vedi Opere , volume 22.
[8] Cfr. il mio articolo “ Sul disastro informatico: fine della storicità ? », in Les Temps Qui Restent (rivista online), aprile 2024, dove mi riferisco in particolare a Benjamin Bratton, The Stack. Software e sovranità , Cambridge, MIT Press, 2015.
[9] Carl Schmitt: Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950), trad. fr. Peter Haggenmacher, PUF 2012. Schmitt gioca sistematicamente sul doppio significato etimologico del greco nomos : legge, condivisione o distribuzione.
[10] Sulla vicinanza tra le tesi di Schmitt sul “Grossraum” e quelle di Samuel Huntington sullo “scontro di civiltà”, cfr. Etienne Balibar, Europa, America, Guerra . Riflessioni sulla mediazione europea, Éditions La Découverte, Parigi 2003, Éclaircissement n° VIII.
[11] È sorprendente che esattamente nello stesso anno un’idea simile sia stata proposta da Hannah Arendt ( Le origini del totalitarismo ) e da Aimé Césaire ( Discorso sul colonialismo ).
[12] Mi distinguo qui in parte dalla tesi di Éric Alliez e Maurizio Lazzarato (a loro volta ispirati al lavoro di Antonio Negri e Michael Hardt: Empire and Multitude , 2000-2004) in Wars and capital , Editions Amsterdam, 2016, mentre traendone diretta ispirazione.
[13] Non c’è impero che non sia centrato su una nazione che si concepisce come una “Grande Nazione” (espressione della Rivoluzione francese contemporanea del confronto con la coalizione monarchica e la spedizione d’Egitto), o come dotata di un destino manifesto . di conquista del continente (1845: annessione del Texas e guerra USA-Messico). Questo sarà oggetto di uno studio speciale. Vedi anche le nozioni di “Grande Gran Bretagna”, Grossdeutschland , “Mondo russo”, ecc.
[14] Prendo in prestito questa nozione da Mohamed Amer Meziane: Imperi sotto la terra. Storia ecologica e razziale della secolarizzazione , Éditions La Découverte, Parigi 2021. Cfr. anche la sua intervista all’emiro Mahieddin: “Per un’antropologia dell’imperialismo”, in Journal des anthropologues, 170-171, 2022.
[15] Traduzione francese in EP Thompson et al., L’exterminisme. Armamento nucleare e pacifismo , Parigi PUF 1983.
[16] La formula compare nell’“opuscolo Junius”, La crisi della socialdemocrazia , scritto da Rosa Luxemburg in carcere nel 1915.
[17] Cfr. in particolare: Samir Amin, Accumulazione su scala globale (Anthropos, 1970); Immanuel Wallerstein: Capitalismo storico, Londra Verso 1983; Il sistema del mondo moderno, 4 voll. con vari editori, 1974-2011); Giovanni Arrighi: Il lungo Novecento, Verso 1994.
[18] Come diceva Marx nella prima edizione del Capitale , rivolgendosi ai tedeschi, e più in generale alle nazioni che non avevano ancora sperimentato la rivoluzione industriale: De te fabula narratur… in questa analisi del “rapporto sociale” generato dal capitale industriale, è in gioco il tuo futuro prossimo o lontano. Un giorno il mondo sarà omogeneizzato sotto il dominio del capitale, a meno che nel frattempo non sia intervenuta una rivoluzione proletaria.
[19] Penso in particolare agli autori francesi della “scuola della regolazione”: Michel Aglietta, Robert Boyer, Alain Lipietz. Ma si veda anche Geoff Mann, In the Long Run We Are All Dead: Keynesianism, Political Economy, and Revolution , Verso, 2017.
[20] L’ interregno secondo Gramsci, da lui definito con una doppia negazione: «Il vecchio è già morto, il nuovo non è ancora nato», è oggi citato ovunque. L’antitesi tra vecchio e nuovo sembra sempre dominata dall’idea di un obiettivo “in sospeso” o telos , ma proprio questa aspettativa rischia di influenzarne il contenuto.
[21] La più interessante è senza dubbio l’idea che si legge tra le righe dei Quaderni del carcere : il regime sovietico riorganizzato da Stalin dopo la fine della “Nuova Politica Economica” e la collettivizzazione forzata dell’agricoltura è anche una forma di “ rivoluzione passiva”.
[22] “Il mondo capovolto”: formula dei Livellatori nella prima rivoluzione inglese. Si veda il mio contributo in A Global History of Revolutions, sotto la direzione di Ludivine Bantigny, Laurent Jeanpierre et al., Éditions La Découverte 2023: “Failure of revolutions? “.
[23] Étienne Balibar: “Verso una nuova critica dell’economia politica: dal plusvalore generalizzato alla sussunzione totale”, in Capitalismo, concetto, idea, immagine. Aspetti del capitale di Marx oggi , a cura di Peter Osborne, Eric Alliez, Eric-John Russell, Kingston University London 2019; “Capitalismo assoluto”, in Neoliberismo mutante. Regola del mercato e rottura politica , redattori di William Callison e Zachary Manfredi, Fordham University Press, 2020.
[24] Questo è ovviamente lo schema preferito dai “teorici” del neoimperialismo (come Hayek, Friedmann, ecc.), che presentavano la politica economica e le “riforme strutturali” da loro auspicate come il ritorno a un’ortodossia economica , in contrapposizione alle eresie ispirate da Keynes e “strizzate gli occhi” verso il bolscevismo (pianificazione, investimenti pubblici, controllo dei prezzi, diritti sociali garantiti, ecc.).
[25] Cfr. Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino. Lineages of the 21st Century, Verso 2009, e Benjamin Bürbaumer, Cina/Stati Uniti. Capitalismo contro la globalizzazione , Éditions La Découverte, Parigi 2024.
[26] Questo è l’argomento particolare del lavoro di Sandro Mezzadra e Brett Neilsson da Border as Method, or the Multiplication of Labour (Duke University Press 2013) a The Politics of Operations. Scavando il capitalismo contemporaneo (Duke University press, 2019).
[27] Un segno spettacolare in tal senso è stato dato durante la pandemia di Covid-19 dalla dichiarazione del direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, dottor Tedros Adanom Ghebreyesus, che denunciava una situazione di “apartheid vaccinale” su scala mondiale (cfr. il mio saggio “Un mondo, una salute, una specie. Pandemia e cosmopolitica”, in Ecrits, III: Cosmopolitica dai confini alla specie umana , Éditions la Découverte 2022.
[28] Che io chiamo più precisamente: “Stato sociale nazionale. »
[29] Étienne Balibar, “La politica del debito”, in Cultura postmoderna, volume 23, numero 3, maggio 2013.
[30] La situazione della Cina è ancora una volta molto particolare poiché, da diversi anni preda delle “bolle” speculative immobiliari, è anche il principale detentore sui mercati finanziari di titoli americani (obbligazioni di Stato), il che le conferisce una capacità interna di influenzare le politiche americane, ma può anche spiegare perché non ha interesse a provare a scuotere il dominio del dollaro (questo punto è molto dibattuto: vedi Michel Aglietta, Guo Bai, Camille Macaire: La corsa per la supremazia monetaria globale. Alla prova della rivalità sino-americana , Edizioni Odile Jacob, Parigi 2022).
[31] Verónica Gago e Sandro Mezzadra: “Una critica delle operazioni estrattive del capitale: verso un concetto ampliato di estrattivismo”, Rethinking Marxism 29, n. 4, 2017.
[32] Possiamo anche pensare alla nozione di “policrisi”, come hanno recentemente evidenziato Adam Tooze e altri che lo hanno seguito, ma in un modo “visto dal basso”.